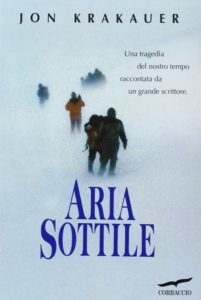 Ho deciso di leggere Aria sottile dopo aver visto il film Everest ed essermi trovato perfettamente d’accordo con la recensione pubblicata qualche settimana fa su Alpinismo Molotov. Mi è venuta voglia di leggerlo perché si intuiva che, affogati nella lattiginosità hollywoodiana, c’erano pezzi di sostanza totalmente diversa, ben più consistenti ed interessanti; ho messo alla prova l’intuizione e ne sono contento, perché Aria sottile è uno splendido racconto, con tanti punti di forza e pochi punti deboli. Qui di seguito proverò a descrivervi gli uni e gli altri, cercando di rovinare il meno possibile la lettura, anche se è impossibile evitare del tutto gli spoiler.
Ho deciso di leggere Aria sottile dopo aver visto il film Everest ed essermi trovato perfettamente d’accordo con la recensione pubblicata qualche settimana fa su Alpinismo Molotov. Mi è venuta voglia di leggerlo perché si intuiva che, affogati nella lattiginosità hollywoodiana, c’erano pezzi di sostanza totalmente diversa, ben più consistenti ed interessanti; ho messo alla prova l’intuizione e ne sono contento, perché Aria sottile è uno splendido racconto, con tanti punti di forza e pochi punti deboli. Qui di seguito proverò a descrivervi gli uni e gli altri, cercando di rovinare il meno possibile la lettura, anche se è impossibile evitare del tutto gli spoiler.
Aria sottile, così come Everest, racconta la spedizione che portò all’evento conosciuto come “disastro dell’Everest”, spedizione di cui Krakauer faceva parte. Va evidenziato che il libro nasce come estensione di un già ampio reportage pubblicato sulla rivista Outside commissionato prima degli eventi e che era la ragione stessa della presenza dell’autore sul posto.
Il primo punto di forza del romanzo è che, al contrario del film, appare scritto con la volontà di spiegare la dinamica dei fatti. Nel film in tutta la giornata cardine della vicenda ci sono solo tre luoghi riconoscibili: il campo 4, la vetta e l’Hillary Step. In ogni occasione in cui i protagonisti si trovano in un punto diverso risulta difficilissimo capire dove siano e spesso anche identificarli nei vortici di neve non è agevole, mentre nel libro la trama scorre molto più comprensibile, per quanto possibile data la situazione caotica e la difficoltà dei testimoni a ricordare lucidamente quegli eventi. Come racconta l’autore:
Durante la fase di documentazione chiesi ad altre tre persone di raccontare un incidente a cui avevamo assistito tutti e quattro in cima alla montagna, e non riuscimmo a raggiungere un accordo neppure su fatti essenziali come l’ora, le parole che erano state pronunciate, o addirittura l’identità dei presenti.
In secondo luogo il romanzo beneficia del non dover comprimere la narrazione entro certi limiti di durata, e quindi del potersi dilungare molto di più per far capire la situazione, dando più spazio sia alle spiegazioni (ad esempio delle ragioni dell’assenza di corde fisse in un determinato punto) sia a dettagli solo apparentemente secondari (come il non utilizzo dell’ossigeno da parte di Boukreev), sia riportando fatti che pur trovandosi sul margine della vicenda contribuiscono non poco a chiarirla, a partire dalla composizione e dalla storia delle altre spedizioni presenti al campo base contemporaneamente a quelle di Hall e di Fischer.
Ancora grazie al maggior spazio (o al semplice desiderio di andare un passo oltre il facile sensazionalismo) il libro spiega benissimo la questione dell’utilizzo dell’ossigeno in alta quota, delle conseguenze della sua carenza nell’organismo, e del difficile equilibrio tra disponibilità di ossigeno e leggerezza del carico, questioni da cui probabilmente sono dipesi in gran parte gli eventi.
Krakauer inoltre riesce ad allargare l’obiettivo non concentrandosi solo sulla giornata della vetta, ma descrivendo tutto il periodo dell’avvicinamento, rendendo così il libro qualcosa che non parla solo di un drammatico incidente ma più in generale di cos’è, in tempi recenti, l’alpinismo sull’Everest. E qui sta quello che per me è in assoluto il suo maggior merito, quello di raccontare una salita all’Everest senza negare la sua essenza epica, ma allo stesso tempo mostrando di cosa sia costituita quest’epica, di come non sia una successione di luminosi slanci eroici, ma piuttosto una somma di sopportazioni che non mancano di far sentire il proprio peso. L’autore lo rende benissimo in un passaggio proprio in apertura del libro
A cavalcioni del tetto del mondo […] a un certo livello, con distacco, comprendevo che la curvatura dell’orizzonte terrestre che si inarcava ai miei piedi era uno spettacolo eccezionale. Avevo fantasticato tanto, per mesi e mesi, su quel momento e sull’ondata di emozioni che lo avrebbe accompagnato, e ora che finalmente ero lì, in piedi sulla cima del monte Everest, semplicemente non riuscivo a radunare le energie sufficienti per concentrarmi.
In una persona come me, appassionata di montagna ma sostanzialmente digiuna di alte quote, le pagine di Krakauer non hanno stimolato il desiderio di tentare l’impresa, ma piuttosto la coscienza della mia inadeguatezza ad essa, e questo è indubbiamente un gran merito, ancor più se messo in relazione ai fatti di cui narra. In questi tempi di guerre minacciate e glorificazioni di guerre passate di una simile onestà intellettuale si sentirebbe il bisogno anche in altri campi.
Altrettanto onestamente l’autore tocca tutte le problematiche connesse al crescente numero di persone che tentano di scalare l’Everest: dall’evidente carenza di esperienza o di preparazione di una parte consistente degli aspiranti scalatori, al sovraffollamento in sé, alla quantità di rifiuti abbandonati sulla montagna, alle questioni economiche relative alle spedizioni commerciali, inclusa la disparità di trattamento tra guide locali e straniere. Su alcuni di questi punti il giudizio di Krakauer mi lascia forti dubbi (vedi sotto) ma in ogni caso non si può dire che nella sua narrazione sfugga alle problematiche, come invece fa il film, al quale diventa persino offensivo paragonarlo. Nota a margine, dal libro è stato tratto nel 1997 anche un altro film, che non ho visto ma che dalle recensioni non pare migliore di Everest.
Il lato più debole del libro mi sembra invece essere la scarsa coerenza tra le evidenze portate ed alcune delle conclusioni che ne vengono tratte, per esempio sul fatto che l’autore consideri migliori le spedizioni commerciali di quelle “tradizionali” perché a suo dire essendo interessate a ripetere l’ascensione negli anni successivi sono più attente a conservare l’ambiente nello stato migliore possibile. La maggior attenzione all’ambiente pare dimostrata dai dati sulle quantità di rifiuti prodotte o recuperate dalle varie spedizioni, ma facendo questa affermazione Krakauer pare dimenticare che gli errori di valutazione che portarono al disastro furono conseguenza anche del bisogno di conseguire un risultato eccezionale (in termini di clienti portati in vetta) nel momento in cui era presente un giornalista di un magazine quotato, che col suo articolo avrebbe potuto fare la fortuna o la disgrazia delle diverse organizzazioni commerciali presenti; fatto questo che l’autore sottolinea più volte nel libro, fino ad addossarsi una parte della responsabilità di quanto successe, ma di cui pare non tenere conto in questo giudizio.
Ancor meno coerente mi pare il giustificare le differenze salariali tra locali e stranieri con il differente costo della vita nelle rispettive nazioni d’origine, anche se bisogna riconoscere che nel sostenere una simile argomentazione l’autore è in numerosa e stimata compagnia. Perché Lopsang Janbu dovesse essere pagato un quarto di Neal Beidleman, che nella gerarchia delle guide del gruppo di Fischer era al di sotto di lui, rimane a mio giudizio una scelta non giustificabile senza tirare in ballo qualche forma di razzismo; un razzismo che peraltro velatamente si affaccia in molte parti del libro in cui si parla degli sherpa, lodati all’infinito ma immancabilmente descritti come sempliciotti superstiziosi. Per onestà va rilevato che il difetto di ritrarre i personaggi non di primo piano in modo eccessivamente schematico sembra essere una caratteristica di Krakauer anche quando tratta di wasp come Ian Woodall, capo della spedizione sudafricana, e che potrebbe quindi essere frutto di una scelta di stile e non di razzismo.
Un’altra incoerenza si riscontra nell’attribuzione delle responsabilità della catastrofe, tanto che con Boukreev, accusato pesantemente nell’articolo originale, poi in modo più sfumato nel libro, ed infine quasi assolto nella postilla, ci fu una lunga querelle, sopravvissuta persino alla morte del russo, al quale si sostituì De Walt, co-autore di Everest 1996 il libro in cui Boukreev replicava a Krakauer. Alla fine di Aria sottile Hall, che perse quasi tutti i membri della propria spedizione, viene giudicato colpevole solo di un eccesso di empatia, mentre Fischer e le sue guide vengono criticate numerose volte, nonostante il fatto che, come fa notare Simone Moro difendendo l’amico Boukreev in un parere che con molta correttezza viene riportato nella postfazione, «Nessun cliente della sua spedizione è morto». In qualche modo Krakauer pare non voler rilevare che, insieme ad un eccessivo ottimismo delle guide e ad una serie di circostanze sfortunate, la vera ragione alla base della catastrofe fu l’inadeguatezza all’impresa di molto clienti e che da questo punto di vista la spedizione di Fischer era in una situazione molto migliore, includendo solo una principiante assoluta su otto clienti, mentre in quella di Hall le persone con insufficiente pratica di alta quota, benché nessuna di loro ne fosse del tutto digiuna, erano almeno cinque su otto.
Aldilà di questi difetti ritengo Aria sottile un libro da leggere, almeno per tutti gli appassionati di montagna, con la libertà di poter rigettare del tutto o in parte le sue conclusioni, ma senza con questo sminuire non solo il fascino del racconto ma anche il desiderio e la capacità dell’autore di rendere comprensibile ad un pubblico non esperto senza ricorrere a eccessive semplificazioni.
Vorrei chiudere segnalando una storia citata marginalmente nel libro, l’impresa di Goran Kropp. Questo svedese, allora ventinovenne, partito da casa sua in bicicletta nell’ottobre del ‘95 con l’obiettivo di scalare l’Everest con le sole sue forze (quindi senza l’ausilio di mezzi a motore, sherpa o bombole di ossigeno), si trovò ad attaccare la vetta una settimana prima di Krakauer. Incontrando molta più neve fresca del previsto nell’ultimo tratto finì per trovarsi a 100 metri di quota dalla cima in notevole ritardo sulla sua tabella di marcia e, anche se in condizioni fisiche ottime, arrivato a quel punto ebbe la lucidità per fermarsi e tornare indietro, rinunciando ad un obiettivo che occupava ogni minuto del suo tempo da nove mesi. Quanto accaduto la settimana successiva darà ragione alla sua scelta, e il fatto che dopo tre settimane di riposo al campo base Kropp sia riuscito a raggiungere la cima e ridiscendere sano e salvo diventa solo un dettaglio, un lieto fine piacevole, ma non necessario. Tra tanti personaggi notevoli proposti dal libro, Kropp è decisamente il più vicino al modo di intendere la montagna di Alpinismo Molotov.




