di Filo Sottile
1. Non una recensione
 Geoanarchia (Armillaria, 2017), il penultimo libro di Matteo Meschiari, è una raccolta di scritti diseguali, una macchia in cui convivono specie vegetali diverse. Gli scritti, apparsi dal 1998 al 2016 come testi a sé stanti, sono accomunati dal tema ambientale, dalla tensione extrapolitica (ovvero la politica fuori dalla polis), dal linguaggio evocativo e asciutto.
Geoanarchia (Armillaria, 2017), il penultimo libro di Matteo Meschiari, è una raccolta di scritti diseguali, una macchia in cui convivono specie vegetali diverse. Gli scritti, apparsi dal 1998 al 2016 come testi a sé stanti, sono accomunati dal tema ambientale, dalla tensione extrapolitica (ovvero la politica fuori dalla polis), dal linguaggio evocativo e asciutto.
Il tema, anzi, è la terra – la Terra – e i modi che abbiamo di percorrerla ed eleggerla a ispiratrice di pensiero, resistenza, condotta.
Queste che leggete sono parole scritte a matita, accalcate negli spazi che contornano i pensieri inchiostrati di Meschiari, note a margine (appunti, sottolineature, cerchiature, asterischi) costitutivamente frammentarie. Le metto in bella con il bagliore dei roghi in Valsusa negli occhi, e il fumo e l’odore di bruciato proveniente dalla Valsangone nel naso. Parole imbrattate di fuliggine.
Il libro l’ho letto un mese fa ed è riuscito di volta in volta a entusiasmarmi, sorprendermi, corrugarmi la fronte, storcermi il naso. Geoanarchia pone problemi. Mi ha costretto a tentare di chiarire i miei orientamenti, a interrogarmi: come declinare la mia militanza ambientale? che strumenti adoperare per esercitarla e comunicarla? che pratiche mettere in campo per acquisire nuove consapevolezze, trovare codici etici ed ecologici?
Quale rapporto l’essere umano (studioso, appassionato, militante) intreccia con la terra e di quali strumenti di indagine potrebbe dotarsi per approfondire la sua conoscenza e arginare i guasti ambientali e sociali del neoliberismo. Forse di questo parla Geoanarchia.
(Arginare? Porre fine! Porre fine!)
Se di questo parliamo, dell’umano e del rapporto con la terra e con la Terra, diventa più chiara la ragione per la quale durante la lettura mi sono tornate così spesso in mente le parole di Ursula K. Le Guin e Stanislaw Lem. Nelle loro storie, lontane migliaia di anni luce da qui, tante volte ho ritrovato il punto di vista ottimale per guardare alla nostra condizione effettiva.
2. The actual condition
Il disastro ecologico e sociale nel quale viviamo sembra non riguardarci. Avveleniamo, ci avveleniamo. Per scrivere queste note sto battendo i tasti di un computer portatile, a pochi centimetri dalla mia mano destra c’è uno smartphone. Sono i due oggetti più vicini a me in questo momento. La loro produzione ha ingenti costi ambientali e sociali. Sono oggetti che uccidono, avvelenano esseri viventi (umani, animali, vegetali), sventrano la Terra, provocano guerra, sofferenza e sopraffazione. E io me li tengo stretti, sono propaggini che mi permettono di fare cose che mi paiono fondamentali, più fondamentali della salute della Terra e di quegli esseri viventi.
Basta spostare un’acca al fondo. Heart diventa earth e possiamo lasciarcelo cantare dagli Hüsker Dü:
Well, the actual condition of my earth
Feels like two hands that are ripping it apart
I keep losing definition
But still I keep on wishin’
It’s the actual condition of my earth.
Il neoliberismo depreda le risorse, distrugge gli ambienti, estingue piante e animali, affama i popoli. Sembra impossibile inchiodare i responsabili, liberarsi dal giogo di questa logica distruttiva, invertire la rotta.
Ma no. Non ce n’è bisogno. Il neoliberismo fa tutto da sé. Sfama i poveri, tutela l’ambiente, pianta gli alberi. Tutto incluso nel prezzo. Purché nulla cambi. Fino all’ultimo respiro.
Una delle riflessioni di Meschiari si intitola emblematicamente Potature. Prende avvio da quelle potature cittadine che riducono gli alberi a totem. Non di rado gli alberi ci restano secchi. Però quel modo di potare permette di intervenire ogni due o tre anni invece che ogni anno. È come mozzarsi la prima falange una volta per tutte, invece che tagliarsi le unghie ogni dieci giorni. “Assurdo? Non troppo, se si pensa che tutta l’immaginazione che ci resta viene allenata per farci risparmiare sul necessario e sperperare sul superfluo”1.
È la logica del risparmio. Possiamo tagliare, fare a meno di un corpo forestale e buttare in quel cesso di cantiere a Chiomonte decine di migliaia di euro ogni giorno per riempirlo di soldatini e pupi corazzati.
E poi c’è l’usa e getta, una logica così pervasiva da divenire invisibile. Nella stessa scuola dell’infanzia in cui le maestre si vantano di aver attivato un percorso di educazione ambientale, tutte le stoviglie della mensa sono monouso.
Se si producessero meno rifiuti, se si riutilizzassero i materiali invece di termovalorizzarli nell’aria, se si studiassero mezzi di locomozione che sfruttano le energie rinnovabili, se si riducesse la produzione di materie plastiche, l’emissione di polveri sottili, di gas serra. Eccetera, eccetera. Tutta fuffa. Tutti quei “si” impersonali implicano azioni senza attori, tutti quei “se” sono monchi di pensiero e volontà che li traduca in azione.
L’indignazione da poltrona è figlia di un’epoca in cui lo spostamento da fermi ha raggiunto il suo culmine. Qualcuno ha immaginato per noi un viaggio (in aereo, su Google Street View, su Marte). Qualcuno dosa la nostra rabbia e confida nel fatto che non varcherà la porta di casa, se non per incollarsi alle bacheche dei nostri social network. Abbiamo firmato una delega, sono altri a occuparsi delle scelte piccole e grandi che coinvolgono i nostri territori e il nostro tempo di vita. Meschiari escogita decine di modi per ribadire questo concetto: abbiamo bisogno di immaginare di poter fare qualcosa di diverso.
E poi farlo.
È in atto un’azione di propaganda massiva. Meschiari ci invita a chiederci cosa intenderemo per ambiente fra cinquant’anni. Le strategie comunicative del mercato globale ci avranno persuasi a “chiamare con lo stesso nome un ambiente degradato per sempre”2?
Non c’è bisogno a dire il vero di forzare lo sguardo al futuro. Grazie al meccanismo del biodiversity offsetting (compensazione della biodiversità), solo un esempio fra molti, si può conseguire contemporaneamente la licenza di assassino ambientale e l’attestato di benemerenza ecologica. Lo analizza bene Re:Common: in sostanza puoi distruggere una foresta pluviale se prometti di tutelarne un’altra altrove. Almeno fino a che esiste ancora un altrove da tutelare.
The actual condition è che il mio cuore e la terra sono a brandelli, ma non smetto di desiderare di ricomporli, di udire il loro battito, seguirlo.
3. Geoanarchia
Il primo geolinguista, ignorando le liriche delicate e
fugaci dei licheni, leggerà al di sotto di queste le
poesie fredde e vulcaniche delle rocce, ognuna delle
quali sarà una parola pronunciata, moltissimo
tempo fa, dalla terra stessa nell’immensa solitudine
e nella più immensa comunità dello spazio.
Ursula K. Le Guin
Geoanarchia. Geo è la Terra, e anarchia che cos’è? Kropotkin per l’edizione del 1911 dell’Enciclopedia Britannica scrisse che anarchia è:
Il nome dato a un principio o a una teoria della vita e del comportamento, secondo cui la società è concepita priva di governo, risultando l’armonia di tale società non dalla sottomissione alle leggi o dall’obbedienza a un’autorità qualsiasi, ma da liberi accordi stabiliti tra gruppi numerosi e diversi, su base territoriale o professionale, liberamente costituiti per le necessità della produzione e del consumo, come anche per soddisfare l’infinita varietà dei bisogni e delle aspirazioni degli esseri civili3.
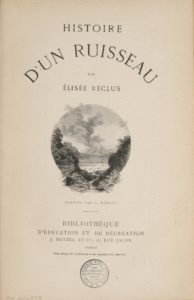 A me di queste parole solo l’aggettivo “civile” pare invecchiato male. “Civiltà”, lo dice bene Ursula Le Guin, è un «termine con il quale, oggigiorno, da noi si intende un’economia capitalista e una tecnologia industriale basata su uno sfruttamento intenso delle risorse umane e naturali»4. Inoltre, a leggere Frammenti di antropologia anarchica di David Graeber e Anarchia come organizzazione di Colin Ward scopriamo che sono diverse le popolazioni che la pubblica opinione faticherebbe a definire civili che si danno forme di governo anarchiche. Ma a Meschiari questo principio, questa teoria della vita e del comportamento, così come li definisce Kropotkin, sembra non bastare, e avanza una proposta: «all’anarchia dovremmo sostituire la geoanarchia, un’anarchia che apprenda tutte le sue libertà, tutti i suoi pensieri, tutte le soluzioni pratiche ai problemi sociali dalla terra, la terra sotto i piedi5» e prosegue ancora: «tutti i principi dell’anarchia sono già nella terra».
A me di queste parole solo l’aggettivo “civile” pare invecchiato male. “Civiltà”, lo dice bene Ursula Le Guin, è un «termine con il quale, oggigiorno, da noi si intende un’economia capitalista e una tecnologia industriale basata su uno sfruttamento intenso delle risorse umane e naturali»4. Inoltre, a leggere Frammenti di antropologia anarchica di David Graeber e Anarchia come organizzazione di Colin Ward scopriamo che sono diverse le popolazioni che la pubblica opinione faticherebbe a definire civili che si danno forme di governo anarchiche. Ma a Meschiari questo principio, questa teoria della vita e del comportamento, così come li definisce Kropotkin, sembra non bastare, e avanza una proposta: «all’anarchia dovremmo sostituire la geoanarchia, un’anarchia che apprenda tutte le sue libertà, tutti i suoi pensieri, tutte le soluzioni pratiche ai problemi sociali dalla terra, la terra sotto i piedi5» e prosegue ancora: «tutti i principi dell’anarchia sono già nella terra».
L’anarchia contro la quale Meschiari sferra i suoi strali è quella che pensa “a contrario”, imprigionata nella trappola della reazione alle mosse del nemico. Meschiari ci chiede di sottrarci a questa logica. Di immaginare spazi di libertà che assecondino le linee ardite delle coste, abbiano per musa i profili delle montagne e si cibino dei miracolosi e cangianti equilibri degli ecosistemi. Non è una fricchettonata. Meschiari chiede di inventare un’anarchia che oltrepassi “né dio, né stato, né padroni” e che sappia ripescare la carica eversiva e immaginifica che ancora brilla nelle parole degli esploratori anarchici.
A me è venuto in mente quest’altro passaggio di Kropotkin:
Se una certa armonia esiste nella natura, se ogni cosa e ogni essere vivente si trovano a essere più o meno adattati alle condizioni in cui vivono è perché sono il prodotto di queste stesse condizioni. Il libero gioco delle forze costruttive e distruttive crea l’equilibrio più durevole fra queste diverse forze. E l’armonia non può che esserne la risultante, sempre variabile, sempre rinnovata da queste forze, secondo i bisogni del momento. L’armonia e l’ordine non sono affatto il prodotto di una volontà divina. Non sono il frutto di leggi imposte da una delle forze attive. Essi si ottengono solo a una condizione, quella di essere un equilibrio liberamente stabilito tra tutte le forze agenti su uno stesso punto. L’armonia non può perdurare che a condizione di essere continuamente modificata, di cambiare aspetto a ogni istante. Il cambiamento continuo è la vita stessa della natura6.
Sono parole da “teoria della vita e del comportamento” più che da dottrina politica, ed è evidente che sono ispirate dall’osservazione del pianeta. Sono le parole del Kropotkin geografo, scienziato prestate al Kropotkin rivoluzionario.
Che la questione sociale è strettamente legata alla questione ecologica Meschiari ce lo mostra chiaramente in Artico nero (ExOrma, 2016), il suo libro precedente. Qui invece ci invita a fare incetta di strumenti rinnovati, per combattere la forma mentis del neoliberismo.
Meschiari chiede ai militanti geoanarchici di trovare di nuovo la capacità di viaggiare, di essere geografi, abitatori di terre esterne. Chiede loro di ricercare un pensiero dell’altrove che rinsangui gli immaginari e li renda resistenti, capaci di reggere l’urto e la contaminazione della propaganda neoliberista. Si tratta a tutti gli effetti di una via cognitiva, poetica, mitopoietica. Da percorrere a piedi.
4. Camminare
Camminare non è un’azione a impatto zero. Quando mi muovo nel bosco lascio orme, odori, rami spezzati. La terra per un certo tempo tiene traccia del mio passaggio. E se poi sui miei passi si sovrappongono altri passi, alla lunga, si crea un sentiero. Il mio cammino si iscrive nel, entra a far parte del, bosco. E questo vale per ogni paesaggio.
Il paesaggio tuttavia modifica il passo. Salite, discese, fondo sabbioso, fondo sassoso, fondo fangoso. C’è un necessario adattamento che è conoscenza. Il passo mi dice il ritmo del paesaggio, il suo fluire, ed è la corrente che connette il paesaggio con il mio mondo interiore.
Camminare è uno strumento di indagine, ci porta sui luoghi e li mette a disposizione del corpo e di tutti i suoi canali percettivi. Camminare è metafora primaria per concepire la conoscenza come un percorso e non come un pacchetto dato. «Camminare introduce nell’essere la categoria di un divenire spazializzato7». Camminare è farsi luogo, radicarsi nello spazio. Camminare è pensiero corporeo.
La logica del camminatore non è binaria: piede destro e piede sinistro non sono in contrapposizione, ma gli elementi necessari al movimento. Il camminatore fa esperienza della molteplicità del mondo: è forzato a prendere coscienza che ogni paesaggio ha una sua giurisdizione, leggi locali e transitorie a cui rapportarsi.
Meschiari invita a camminare: per uscire, per «disobbedire all’immobile», per riconoscere i ritmi, cercare le connessioni e disegnare mappe dei paesaggi che attraversiamo.
5. Camminare paesaggio
Il paesaggio, scrive Meschiari, è «qualcosa di tangibile nella sua parte più concreta (il territorio, la geografia fisica, il mondo naturale), ed è abbastanza intuitivo nella sua parte concettuale (etica, estetica, filosofica, cognitiva). In altre parole, il paesaggio aiuta a entrare nel mondo delle idee tenendo i piedi per terra»8. Attraversare un paesaggio è una maniera per esercitare il pensiero laterale, la sua natura dinamica e transitoria ci suggerisce di accettare il frammento, l’incompiuto e il confine incerto come rivelazioni del reale.
“Camminare paesaggio” è una delle pratiche che Meschiari suggerisce al militante geoanarchico. Il paesaggio contiene pensiero e può ispirare nuove organizzazioni dello stesso.
Come si fa a camminare paesaggio? Meschiari dice che si parte con l’immaginare: rendere cioè per immagini le connessioni che non balzano all’occhio, ai sensi. Immaginare l’orogenesi, il passaggio di un ghiacciaio, un sisma, un incendio. Significa percorrere lo spazio a cavallo di una macchina del tempo.
Poi si guarda con particolare attenzione ai dettagli infimi e a ciò che rimane fuori dalle inquadrature. Poi si tocca. Si entra in contatto con il paesaggio con il corpo e come un corpo. Poi si ascolta. Cos’è ascoltare lo dice bene Ursula Le Guin:
[…] Il suono è locale, mentre non lo è la vista. Il suono è delimitato dal silenzio; e non emerge dal silenzio a meno che sia piuttosto vicino, nello spazio e nel tempo. Sebbene stiamo dove stava un tempo il cantante non possiamo sentire la sua voce; gli anni l’hanno portata via sulle loro maree, l’hanno sommersa. Il suono è una cosa fragile, un tremore, delicato quanto la vita9.
Dopo aver ascoltato il paesaggio lo si pensa, che significa smettere di pensarlo, perché gli elementi e le idee che lo costituiscono hanno trovato concretezza nell’immagine della sua morfologia. E poi lo si ricorda: “ricordare significa trasformare in racconto la terra perché si sciolga più lentamente10”.
Un paesaggio percorso immergendovi il corpo, pestando il terreno, toccando, annusando, raccogliendo, magari infortunandosi, entra in noi. Entra a far parte dei nostri pensieri, delle nostre memorie, della nostra carne. Quella stessa carne, quello stesso corpo che a volte decidiamo di schierare come scudo a difesa della terra.
Ho accompagnato Wu Ming 1 in diverse delle interviste preliminari alla scrittura di Un viaggio che non promettiamo breve, la prima domanda era sempre: “perché proprio qui?” E immancabilmente le persone intervistate per rispondere partivano a descrivere com’è fatta la Valsusa, come se l’idea di essere contrari alla Torino-Lione e al modello di sviluppo economico che la ispira fosse una cosa appresa grazie alla conformazione orografica o sui sentieri, sul greto della Dora, nei boschi, sui bricchi.
6. Immaginare
I roghi in Valsusa ancora non si erano spenti del tutto e già nella mailing list dei comitati No Tav si affacciavano gli interrogativi – che fare ora? – e le proposte. E ognuna di queste ipotetiche azioni concrete da compiere nel presente era un’immagine della Valsusa futura, una camminata in una valle che ancora non esiste.
Abbiamo bisogno di immagini per resistere, è uno dei leit motiv di questi appunti di resistenza ecologica, abbiamo bisogno di idee che ci permettano di tenere testa al concatenarsi di morte che abbiamo innescato. Che ci preservino la vita.
La Sicilia sta su tre colonne. Una è gravemente lesionata e Colapesce, che è sceso così in profondità da scoprirlo, è rimasto là sotto a sorreggere l’isola.
Ogni paesaggio ha il suo mito. Dobbiamo chiederci di che mito necessitiamo oggi nei posti in cui viviamo. Dobbiamo immaginare una narrazione che ci dia tempo a venire, un racconto che ci conduca nel pianeta futuro e ci ritagli uno spazio in quel paesaggio.
Per fare questo abbiamo bisogno degli strumenti della poesia, dell’arte. Ci servono acrobazie, immagini alate e voli pindarici per permettere al pensiero razionale di sfuggire alle trappole neoliberiste del ripristino ambientale, delle compensazioni, delle antinomie fra salute e lavoro, fra ambiente e sviluppo. L’immaginazione – dice Meschiari – non è antitetica alla realtà, comunica con essa in maniera freatica. Dobbiamo saper essere scienziati, per comprendere al meglio la situazione, e artisti, per disegnare un sentiero di salvezza.
7. Il selvatico
Abbiamo bisogno di lasciarci ispirare da modelli di gestione che funzionano. Il selvatico, ciò che non possiamo addomesticare, ciò che abbattiamo, estirpiamo, estinguiamo, perché non rientra nelle griglie sociali ed economiche nelle quali incaselliamo il mondo, si gestisce da sé. Osservarlo può esserci d’aiuto, addirittura farci da guida.
Forse, propone Meschiari, dobbiamo smetterla con il controllo del selvatico e passare a un controllo selvatico, alla maniera del selvatico. Osservare, riprodurre l’autogestione degli ecosistemi, le modalità che hanno escogitato per rinnovarsi, gestire la quotidianità e gli eventi straordinari.
Ovviamente per l’essere umano tutto ciò significa fare meno.
Esiste un piano di realtà, il giardino-utopia dei Nna Moy, in cui “lo scenario è identico dappertutto: colline, campi, parchi, boschi, villaggi. Una monotonia fertile, bella, priva di stagioni. Il terreno coltivato e quello selvatico hanno un aspetto esattamente identico. Le poche specie di piante sono tutte utili, danno cibo, legna o fibra. Non c’è vita animale, a parte i batteri, alcune creature che assomigliano alle meduse negli oceani, due specie di insetti utili e i Nna Mmoy”11. I Nna Moy sono i superstiti di un esperimento di ingegneria ambientale che ha eliminato dalla realtà ogni complicazione, ogni minaccia, ogni inquietudine, ogni oggetto inutile all’esistenza dei Nna Moy. Il pianeta in effetti è stato tagliato su misura per loro e i loro bisogni. Gli ingegneri si sono dimenticati però che complicazioni, minacce, inquietudini, inutilità sono necessarie all’equilibrio degli esseri umani. I Nna Moy, privati di tutto questo, hanno dovuto trovare il modo – ed è un linguaggio infinito e cangiante – di fabbricarsi le loro necessarie complicazioni e inutilità.
Se i paesaggi in cui viviamo, sembrerebbe dirci Meschiari, sono dei giardini dobbiamo aprirli al selvatico, lasciargli spazio. Quell’inquietudine che il selvatico ci trasmette è estremamente più vitale dell’ordine che vorremmo imporre, l’inconoscibilità ultima del selvatico è un presidio di resistenza all’omologazione degli spazi, dei tempi, delle pratiche, dei corpi. È selvatica la fonte della vita dalla quale siamo sorti e dalla quale abbiamo l’impressione di esserci separati completamente. E di bere quell’acqua abbiamo ancora bisogno.
È un paradosso. Coltivare il selvatico. Avventurarcisi dentro.
8. Alberi (e radicalità)
Il più obliquo degli strumenti che Meschiari propone è quello del camminare alberi. Afferro solo in parte il suo discorso, ma sono pronto a recepirlo. La maggior parte delle cose che ho scritto per Alpinismo Molotov ruotano intorno alle piante.
Gli alberi disegnano lo spazio. Lo accolgono e ne sono accolti. Quando gli alberi non ci sono più ce ne accorgiamo in una maniera speciale.
È l’ultima domenica di ottobre, sono allo spazio sociale VisRabbia di Avigliana. Sembra di stare in un bicchiere di acqua e anice, c’è odore di bruciato e tira vento. Ogni “come va?” che scambio è accompagnato da scuotimenti di capo, le mani vanno a indicare di là, all’indiritto, dove ancora si lotta con le fiamme. Alberto Perino mi dice che la pineta di Pampalù non esiste più e che vive la situazione per la seconda volta nella sua vita. Dice che sul finire degli anni ‘50, inizio anni ‘60, un altro grande incendio colpì la Val Cenischia. I pini bruciati in questi giorni sono nati dopo quell’incendio. E ora di nuovo non ci sono più.
L’albero è figura dell’abitabilità del cosmo dice Meschiari. Laddove c’era la pineta di Pampalù ora è un paesaggio di orrida bellezza, desolante, che muove al silenzio, alla cautela, al groppo in gola. Il colonnato di tronchi arsi, la cenere a terra: ora tutto dice inospitalità.
Appena si esce dalla zona morta molti di quelli che riprendono la favella sono presi dalla frenesia: piantumare ora! rimboschire subito!, dicono.
Siamo agli sgoccioli di agosto e con Sara e Miriam siamo per l’ennesima volta nel Var, sul sentiero litoraneo che dalla spiaggia dell’Escalet va a Cap Taillat e poi ancora verso Cap Lardier.
Questa è la prima volta che percorriamo questo cammino con la morte nel cuore. Che il 24 luglio scorso c’è stato un incendio molto esteso lo scopriremo più tardi, per ora sappiamo solo che della macchia mediterranea che ben conosciamo non è rimasto altro che cenere. Sul capo gran parte dei pini manca all’appello. Esco dal sentiero e scruto con attenzione il terreno. Percorro la terra con le dita e con gli occhi, poi scosto un guscio abbrustolito di lumaca, e vedo un puntolino verde. L’occhio impazzito corre a cercarne altri. E ci sono. Qua e là, dai ceppi abbrustoliti, spuntano germogli nuovi, brillanti. Chiamo Sara e Miriam, indico una piccola pala di fico d’india: è viva, è sopravvissuta. Poi riprendiamo a camminare, ma gli occhi sono sempre lì a spiare la vita che resiste alla distruzione. Mi gingillo con un pensiero, finché non vinco la ritrosia e lo esprimo ad alta voce: “forse alla fine questi germogli sono la miglior immagine della radicalità”.
L’incendio di Mompantero sembra decisamente più grave di quello che ha colpito Ramatuelle e La Croix Valmer, ci vorrà ben più di un mese prima che la vegetazione torni a colonizzare la terra. Per ora l’ex pineta è una concretizzazione fisica e spaziale dell’idea della morte. Capisco bene chi vorrebbe mettere subito mano alle vanghe e riportare la vita. Ma così facendo perderemmo un’occasione. Sarebbe un po’ come coprire le nostre responsabilità: il cambiamento climatico indotto dai nostri comportamenti, la mancanza di cura e pulizia dei boschi, i gretti interessi degli incendiari. Tutto nascosto da una selva di teneri alberelli.
 (Sono arrivato a questo punto di questo paragrafo quando Luca Giunti rilascia a Radio No Tav questa intervista. Il sentire è il medesimo, ma le sue parole sono molto più precise e molto più ampie delle mie e condizionano pesantemente quelle che sto per scrivere).
(Sono arrivato a questo punto di questo paragrafo quando Luca Giunti rilascia a Radio No Tav questa intervista. Il sentire è il medesimo, ma le sue parole sono molto più precise e molto più ampie delle mie e condizionano pesantemente quelle che sto per scrivere).
Forse invece, laddove sentiamo che ci è stato strappato – ripping apart – il cuore, è rimasto un pezzo di radice sano che può ancora germogliare, che resiste al disastro e che ha voglia di ripartire per un nuovo corso, più consapevole. Forse, prima che le prime piante pioniere riescano a ripopolare quel paesaggio, possiamo andare a visitare quel posto e pronunciare ad alta voce le domande che come tronchi arsi sono rimaste in piedi, e cercare nella terra, se siamo buoni di trovare delle risposte.
Saranno le cause di quegli incendi e non l’assenza di quei pini a spazzarci via.
9. Alle pompe!
Credo che Geoanarchia sia un libro da leggere, fonte di riflessioni importanti, ma, come anticipato nelle prime righe di queste note, mi ha destato anche non poche perplessità e giramenti di gonadi. Ecco le cose che non mi hanno convinto.
Meschiari, lo si capisce fin dalle prime righe, non sceglie mai a caso le parole, è un cultore dell’esattezza, ma quell’esattezza in questa raccolta a volte diventa astratta, priva di concretezza. Il suo pensare paesaggio qui è privo di Storia e di storie. Il suo precedente libro, Artico nero, mi pare molto più efficace nel tentativo di produrre immagini che descrivano il presente e siano noccioli di resistenza per il futuro, Nel Diluvio, il racconto ambientato in Alaska in cui racconta dell’erosione delle coste e delle vite, ne è per me l’esempio più alto.
La proposta politica di Meschiari, così com’è formulata in queste pagine e come io la recepisco, rischia di risultare solipsistica. Manca la collettività, la forza motrice dell’intelligenza collettiva, la potenza d’urto dell’organizzazione dal basso, la sola che davvero – io ne sono convinto – può cambiare le sorti del governo dei territori, limitarne lo sfruttamento. La mia piccola esperienza di militante No Tav mi dice che si resiste davvero se si parte e si torna insieme.
Così com’è formulata la critica all’anarchia che pensa a contrario (e che, in barba a ogni strascico della Prima Internazionale, può essere estesa in generale a tutta la sinistra radicale) rischia a mio avviso di indirizzare a smobilitazioni pericolose. Wu Ming 1 qualche giorno fa ha scritto:
È orribile, è schifoso doversi occupare dei fascisti. Non conosco nessuno che lo faccia volentieri. Se non ci fossero i fascisti, avremmo più tempo, più concentrazione per affrontare altre urgenze. Urgenze enormi, mondiali: lo sconvolgimento climatico già in corso, le siccità e carestie, la crisi idrica globale, l’esaurimento delle risorse, la devastazione del territorio, le guerre e gli esodi che tutto questo provocherà… Tutti disastri causati dal capitalismo, il modo di produzione più cieco, predatorio e di corto respiro che sia mai esistito sul pianeta12.
Se vogliamo chiedere alla terra modelli di vita che ci aiutino a vivere più libere, più liberi, nella tensione al pieno sviluppo individuale e alla soddisfazione dei bisogni di ognuna e ognuno, ci tocca presidiare il territorio politico, non lasciare spazio al fascismo, alle false soluzioni che rafforzano i problemi e la logica distruttiva del capitalismo.
Tuttavia abbiamo bisogno di libri come Geoanarchia, abbiamo anzi bisogno di una molteplicità di appunti di resistenza ecologica: di condividere pratiche, immagini, intuizioni, racconti, storie. Fra i meriti specifici di queste pagine ce ne sono due che mi preme segnalare. Il primo: Meschiari mi pare che ci inviti a studiare di più, a muovere il culo, andare nei posti, metterci il corpo e raccontare ciò che vediamo, ciò che tocchiamo. Secondo: mi pare un invito esplicito ai militanti, ai narratori, agli scienziati perché colmino ognuno le proprie lacune e diventino più radicali, più poeti, più scientifici, più camminatori. Più coraggiosi.
Le prime righe di Geoanarchia sono queste:
Quasi certamente lasceremo ai nostri figli e ai figli dei nostri figli una terra peggiore della nostra. Quando penso a un mondo peggiore, [penso] alla caduta di tutti gli ecosistemi terrestri come li abbiamo conosciuti fin qui. Per fare fronte al collasso, l’uomo svilupperà tecniche di sopravvivenza alimentare, ambientale e sociale, ma non è detto che sarà in grado di resistere veramente. Perché la tecnica non serve a niente senza una mente in grado di affrontare con coraggio e ispirazione le privazioni e le perdite che ci attendono.
E per me fanno rima con queste di Stanislaw Lem:
Mi limitai a rilevare che non mi intendevo troppo di futurologia. Tarantoga replicò che nessuno, in genere, si intende di pompaggio, ma tutti accorriamo quando sentiamo gridare “Alle pompe!”13
Porre fine! Porre fine! Alle pompe! Alle pompe!
[1] M. Meschiari, Geoanarchia, appunti di resistenza ecologica, Armillaria, 2017, p.32
[2] Ibidem, p. 49
[3] Riportato in F. Codello, Né obbedire, né comandare, lessico libertario, Eléuthera, 2009
[4] U.K. Le Guin, Su altri piani, Nord, 2005, p. 114
[5] Meschiari, Geonarchia, p. 39
[6] P.A. Kropotkin, Les Temps Nouveaux, Parigi, La Révolte, 1894, p.12, riportato nell’introduzione di Ursula Bedogni a P. A. Kropotkin, La morale anarchica, Stampa Alternativa, 1999.
[7] M. Meschiari, Geoanarchia, cit, p. 125
[8] Meschiari, Geoanarchia, cit, p. 78
[9] U.K. Le Guin, Il diario della rosa, Nord, xxxx, p. 24
[10] Meschiari, Geoanarchia, cit, p. 92
[11] U.K, Le Guin, Su altri piani, cit., p. 211
[12] Wu Ming 1, Antifascismo e anticapitalismo nell’Italia di oggi. Note sul conflitto surrogato e quello vero
[13] S. Lem, Il congresso di futurologia, Marcos y Marcos, p.

