di Simonetta Radice
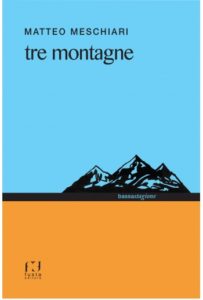 Faccio sempre molta fatica a trovare dei libri di montagna che davvero mi piacciano. Mi annoio da morire con i récit d’ascension, mi irrita la retorica della grande impresa, detesto le descrizioni stereotipate del paesaggio alpino, locus amoenus o locus horridus che sia. Per questi motivi e per molti altri ho amato invece tantissimo Tre Montagne (Fusta Editore, 2015), il primo romanzo di Matteo Meschiari, scrittore, antropologo e studioso del paesaggio.
Faccio sempre molta fatica a trovare dei libri di montagna che davvero mi piacciano. Mi annoio da morire con i récit d’ascension, mi irrita la retorica della grande impresa, detesto le descrizioni stereotipate del paesaggio alpino, locus amoenus o locus horridus che sia. Per questi motivi e per molti altri ho amato invece tantissimo Tre Montagne (Fusta Editore, 2015), il primo romanzo di Matteo Meschiari, scrittore, antropologo e studioso del paesaggio.
Il libro è in realtà una raccolta di tre racconti: in Svernamento, un vecchio parte per un’ascensione – forse l’ultima – portando con sé un bagaglio di ricordi forse troppo pesante. Primo Appennino è invece una rivisitazione dell’epopea di Gilgamesh in chiave partigiana e racconta dell’amicizia di due uomini “dove finiscono le mulattiere”. Pace nella Valle, infine, è il dialogo ritrovato tra un padre e un figlio in un bosco primordiale, per una battuta di caccia che porterà entrambi molto lontano. Per usare le parole dell’autore, il libro è «una stratificazione di geologie personali e temporali molto particolari. La sua origine è assai lontana perché il primo pezzo, Svernamento l’ho scritto nel 2000, poco dopo Pace nella valle mentre Primo Appennino, quello centrale è più recente e risale a circa tre anni fa.»
Tre Montagne colpisce innanzi tutto per la potenza evocativa delle descrizioni d’ambiente. Tanto che viene il dubbio che proprio l’ambiente, lo spazio e la montagna siano i veri protagonisti dell’opera, mentre le persone rischino costantemente di esserne inghiottite.
Ho scritto di questo libro in mailing list e sono stata felicissima quando ho saputo che avrei potuto facilmente intervistare Matteo, per dare voce e condividere alcune suggestioni che mi avevano particolarmente colpita durante la lettura.
Non avevo messo questa domanda tra quelle da farti, ma non posso farne a meno: come fai a descrivere la montagna così, a creare queste immagini così potenti e così vivide?
Credo si tratti di un mix di esercizio e di ribellione nei confronti di una letteratura che mi disgustava. In realtà, la mia ricerca ha da sempre molto a che fare con il paesaggio e sono arrivato a trattarne in antropologia e in geografia proprio perché me ne interessavo già da molto prima, come scrittore. E parecchio tempo fa – andavo ancora all’università – mi ero chiesto che cosa si sarebbe potuto fare per non descrivere i paesaggi nella solita maniera. Una cosa che mi aveva irritato moltissimo era tutta quella letteratura che usava il paesaggio come cassa di risonanza dello stato d’animo dei personaggi. Ho cominciato molto tempo fa una riflessione su questo, ho iniziato a leggere autori che mi sembrava trattassero il paesaggio in maniera diversa e contraria a quella emotiva, impressionistica o peggio ancora psicologica e quindi da una parte c’è stato questo tipo di lavoro, dall’altra ho letto anche molto di geologia e glaciologia e per mia passione mi sono documentato su quelle che sono le dinamiche geomorfologiche. Infine, per tanto tempo ho fatto free climbing, ho praticato alpinismo, e naturalmente a quel tempo avevo un rapporto molto diretto con la montagna. Infine, nel momento in cui si è trattato di trasporla in parole, ho anche rielaborato certe vecchie descrizioni delle guide del CAI, eliminando la componente eroica (hai presente certi passaggi del tipo: “in uno slancio finale”, “per facili roccette”…) e valorizzando altri aspetti che sono veramente belli. Per me, la storia del vecchio in fondo è quasi un pretesto, quello che mi interessava davvero in Svernamento era provare a scrivere una micro enciclopedia del paesaggio alpino all’interno di quel racconto. Mi piace molto osservare le cose e provare a riprodurle attraverso la parola. Mi piace leggere di glaciologia e cercare quegli autori per cui il paesaggio non è una cartolina sullo sfondo di vicende umane, ma una vera e propria fruizione narrativa e letteraria che diventava quasi dominante. Un autore per me molto importante in questo senso è Francesco Biamonti, che ha descritto i paesaggi e la montagna ligure in un modo stupendo.
Una delle cose che mi ha colpito di più in Tre Montagne è la presenza imponente e quasi ingombrante di una natura del tutto indifferente alle sorti degli uomini e alla loro ricerca di senso, di una natura estranea. Hai voglia di approfondire questo punto?

Il Crinale modenese a Fanano, dove si svolge buona parte di Primo Appennino. (Cliccare per ingrandire)
Riesco a risalire a un momento ben preciso in cui questa cosa è stata chiara per me. Ero un ragazzo, avrò avuto tra i 14 e i 15 anni, avevo letto vari testi di Tolkien e mi chiesi a un certo punto come sarebbe stato riscrivere Il Signore degli Anelli eliminando tutte le persone. Quest’idea si è trasformata presto in un progetto poetico perché, per una breve stagione, con un amico poeta che si chiama Francesco Benozzo, abbiamo scritto un manifesto che si intitolava Scrivere Paesaggi e, per una breve stagione, abbiamo dato vita a quella che poi abbiamo chiamato la “letteratura di puro paesaggio”. Si trattava di esperimenti di scrittura fatti per costruire pezzi letterari in cui la presenza umana fosse il più possibile eclissata, paesaggi inumani o addirittura disumani e abbiamo prodotto, seguendo quest’idea, una ventina di testi, pezzi che non ci siamo mai preoccupati di pubblicare ma che poi hanno influenzato moltissimo la nostra produzione successiva. In Italia, tutti i discorsi sul paesaggio sono passati attraverso la porta principale dei dipartimenti di estetica e non si capiva per quale ragione non si potesse parlare di questo argomento senza introdurre l’elemento estetico, il bello. Noi eravamo molto infastiditi da questa cosa e abbiamo quindi provato a lavorare su una scrittura che escludesse tutto questo, una scrittura “a togliere”, pur senza arrivare alla poesia alla Ungaretti. Volevamo fosse una scrittura ben presente, che abbiamo nutrito con letture di botanica, di geologia, di stratigrafia, di sedimentologia e tutto questo ovviamente ha lasciato una traccia anche nei lavori che abbiamo portato avanti individualmente in seguito. In Svernamento, per esempio, i protagonisti sono le montagne ma l’idea è politica, non c’è un giudizio ideologico, morale o etico; l’idea è quella di poter parlare di una terra a prescindere dall’uomo. Si tratta per me di un itinerario necessario per uscire dalla dimensione dell’antropomorfizzazione e per non cadere in errori come quello dello sviluppo sostenibile, assurdità di questo tipo che sono sempre sviluppate in prospettiva umana. Allenarsi un po’ alla disumanità del paesaggio per me è un gesto politico necessario, un gesto anarchico, che dobbiamo fare verso noi stessi.
A proposito di disumanità del paesaggio, in Pace nella Valle, mi sembra ritorni un concetto che hai espresso in Sistemi Selvaggi: la nostalgia dello stato selvatico, le luci e le ombre della foresta che lasciano un ricordo invisibile/indelebile sul pelo dei leoni di montagna che erano leopardi. Vorresti approfondire questo tema?
Da un lato, oggi c’è un distacco abissale tra noi e la dimensione selvatica, dall’altro c’è la capacità del neo liberismo e del capitalismo di appropriarsi anche di questo discorso, di trasformare l’idea di selvatico in un brand, con un’operazione che comporta necessariamente la perdita di riflessione a favore di una trasformazione a fini commerciali e mediatici, una spettacolarizzazione agghiacciante, quella della Wilderness 2.0, come la chiamo io. Sul selvatico ci sarebbero tantissime cose da dire, ma personalmente non ne ho una nostalgia nel senso del desiderio di recupero di questa dimensione, perché penso che ormai ce la siamo giocata definitivamente. Però, ho fiducia nella possibilità di riuscire a sviluppare delle strategie di resistenza a tutto l’assedio che viviamo, attraverso una riflessione sul selvatico e attraverso l’esperienza di situazioni selvatiche. In realtà, devo dire che la mia idea di selvatico non è molto rappresentabile con le immagini tradizionali, la foresta, il ghiacciaio, la traversata dei monti Appalachi o cose del genere. Per me, il selvatico è come un cubo di cemento che si materializza come il monolite di Kubrick, un corpo estraneo che si materializza all’interno della tua stanza. È qualcosa di completamente refrattario, inspiegabile, resistente a ogni processo di interpretazione o di umanizzazione, tu giri intorno a questo cubo di cemento, ci puoi mettere un vaso di fiori sopra per renderlo più bello, lo copri con una tovaglia perché ti da fastidio, però finisci sempre a sbatterci col mignolo del piede ed è lì che ti svegli. Ecco, per me il selvatico è questo, non ha a che fare con qualche forma di idilliaco ritorno alla natura, è qualcosa che ha più a che fare con il senso del limite e della morte.
E infatti nelle storie di Tre Montagne la morte e la solitudine sono elementi ricorrenti. È possibile che esista una dimensione comunitaria a dare una risposta all’assenza di senso che ci circonda, oppure la natura non è che una cassa di risonanza della nostra solitudine esistenziale?

Il Ghiacciaio del Money dal Bivacco Martinotti (Valle d’Aosta, Gran Paradiso). Il ghiacciaio oggi è quasi scomparso, la foto risale al 1983. (Cliccare per ingrandire)
La natura è una cosa a parte, è se stessa indipendentemente da ciò che pensiamo. Non riesco a considerarla come qualcosa in cui siamo ospitati, la vedo piuttosto come qualcosa di non intelligibile. Usando un parolone, wilderness e natura appartengono più all’ordine di un’ontologia negativa, all’ordine di quello che non c’è, più di quello che c’è. Detto questo, il discorso della comunità è una cosa su cui continuo molto a riflettere (e non solo io, basti pensare a tutte le riflessioni di Blanchot o di Agamben con La comunità che viene: ce la stiamo raccontando da tantissimi anni sul discorso della comunità, senza arrivare a capire bene che fare). Secondo me quello che è in realtà comunità sono certe pratiche di condivisione, senza che siano troppo teorizzate, nemmeno a livello politico. Io di base sono anarco-individualista, e vedo e ho una profonda nostalgia della comunità quando penso alla Resistenza, proprio a quel particolare periodo storico, perché è una storia di famiglia, che ho respirato in casa fin dalla generazione dei miei nonni e credo che una dimensione di comunità sia davvero possibile solo nella resistenza. Oggi la resistenza è cambiata e ha preso forme diverse, ma non riesco a cogliere la possibilità di un’esistenza di una comunità pacifica, vedo la presenza di una comunità che diventa tale unendo forze e energie proprio perché si colloca in una condizione di resistenza, quello che crea la comunità è il fatto che esista qualcosa a cui resistere.
In Svernamento, in una delle pagine di diario del vecchio, si parla di poetica dei margini. di cose che escludono nella vicinanza, negando il contatto. Se ne parla a proposito della descrizione di una parete di roccia scavata, della precisione della percezione che vorrebbe diventare conoscenza, ma che per ovvie ragioni non può. Si parla di una poetica che genera poca poesia, hai voglia di approfondire questo punto?
Quando ho scritto quel pezzo mi trovavo a Parigi, si tratta di uno stralcio di un mio diario che poi ho introdotto nel racconto. In quel periodo ragionavo su una Parigi invasa dai ghiacciai… è stato un anno molto alpino per quanto urbano, perché pensavo solo a roccia e ghiaccio. Devo dire che ho un rapporto molto particolare con lo spazio, mi interesso allo spazio perché lo sento in modo quasi patologico, come quando sei in montagna ma stai guardando a valle e percepisci la presenza fisica della roccia alle tue spalle, oppure come accade quando sei al buio, non vedi le cose ma senti gli oggetti anche se non li stai toccando perché stanno occupando spazio, sono masse presenti. Ecco, questa è una cosa che io ho molto sviluppato e sentito quando facevo alpinismo e free climbing. E pensando a queste attività, a questa dimensione silenziosa dove si usa l’intelligenza motoria per individuare il giusto appoggio, l’appiglio e la distribuzione del peso, fino quasi ad arrivare a una forma di danza… tutto questo per me è molto poetico, ma è un poetico che ha molto poco a che fare con le parole. C’è anche un altro punto di Svernamento dove ho provato a raccontare quella sensazione che tutti noi che andiamo in montagna abbiamo provato almeno una volta salendo o scendendo una pietraia di blocchi fermi, una sensazione vicina allo stato di grazia per cui metti il piede nel posto giusto e riesci quasi a saltare… questo tipo di esperienza ho cercato di esprimerla soprattutto nella poesia – non so se ci sono riuscito – ma la mia idea era proprio di farlo attraverso un tipo di poesia che lasciasse perdere il chiacchiericcio interiore e il flusso di coscienza, anche se quando togli queste cose ti ritrovi davvero con poco, ti ritrovi con il corpo e con lo spazio, con lo spazio naturale. Non si tratta di rincorrere un minimalismo alla Ungaretti o alla Montale, io uso comunque tante parole, ma cerco di non usare quelle che raccontano la mia psicologia, perché non frega niente a me, figuriamoci agli altri.
Cito ancora dai diari del vecchio: andare a fare bellezza dove si consuma l’assurdo, la negazione, il nonsenso, il divorzio dalla Terra. Fare gesti di riparazione, riparazione della poesia, proprio là dove si è prodotto l’irreparabile. Farlo con la coscienza che solo così si fa anarchia, solo riequilibrando il macigno caduto con l’ala di una parola. Che legame c’è tra bellezza e anarchia?
Anche qui è importante capire quali sono i miei riferimenti nel discorso anarchico. A me piacciono gli anarchici di prima generazione, quelli che erano geografi: Élisée Reclus, Pëtr Kropotkin, Mosè Bertoni, tutta gente che ha riflettuto sull’anarchia a partire dal rapporto con la terra, una cosa che l’anarchia storica non fa quasi più, perché c’è ancora quest’idea legata a un certo marxismo che il discorso politico abbia a che fare solo con le città e con la classe operaia. Posso anche essere d’accordo su questo, ma a me piacciono molto questi primi anarchici proprio perché avevano saputo affrontare un discorso sulla terra che ora si è perso. Élisée Reclus, per esempio, aveva creato una connessione interessante con riferimento a una divinità germanica, Freyja, che era nello stesso tempo dea della terra e della libertà. Reclus, dopo aver passato un periodo in prigione, deluso dagli amici e dalla fine della Comune di Parigi, a un certo punto decide di andarsene in montagna e scrive un libro che si intitola Storia di una montagna, un libro straordinario in cui riesce a rendere benissimo quest’idea di come la montagna sia un’enciclopedia di ogni tipo di riflessione sulla libertà e questo per me è automaticamente bello, è un progetto che implica l’andare in montagna riflettendo sulle forme della montagna stessa e sulle possibili forme di ricerca della libertà, sia per l’individuo solitario che per gruppi umani. È una forma di poesia che non ha a che fare con la storia e c’è una bellissima frase di un poeta che si chiama Kenneth White che dice che non è tanto importante il dialogo tra le persone, ma quello tra l’individuo e il cosmo. E questo tipo di dialogo è bellissimo perché dimostra che anche un anarco-comunista come Élisée Reclus aveva capito e sapeva che per fare comunità occorrono anche lunghi periodi di solitudine, e questa è una cosa che, nel migliore dei mondi possibili, dovremmo veramente fare tutti: concederci dei periodi di isolamento, per provare a ritrovare il dialogo con il cosmo.
Le fotografie sono di Matteo Meschiari, che ringraziamo. Nella foto in chiusura all’intervista, un’altra fotografia del Crinale modenese a Fanano, dove si svolge buona parte di Primo Appennino.



marco.gentili
| #
Bellissima intervista in cui in molte parti mi sono ritrovato più, grazie alla mia passione per la fotografia e l’alpinismo che conseguentemente porta alla solitudine e il dialogo con la Natura/cosmo.
Comprerò sicuramente il libro di Matteo Meschiari, visti i temi interessanti e molto affini al mio pensiero. Sicuramente cercherò di prendere anche il libro di Élisée Reclus, grazie della citazione e del consiglio.