di Mr Mill
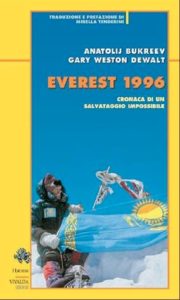 Ci sono eventi che diventano perno per una molteplicità di narrazioni, sia per stile che per punti di vista. Quando si tratta di eventi tragici avvenuti in montagna spesso quel che si legge tra le righe dei primi resoconti giornalistici ha il tono sensazionalistico, per poi virare su quello scandalistico nel momento in cui si procede nel tentativo di individuare il fattore unico e determinante – magari nella carne e nelle ossa di un o un’alpinista – della tragedia, in un giochetto che ha poco senso giacché si svolge tutto ex-post. Arrivano poi le ricostruzioni più circostanziate, scritte da chi è in possesso degli strumenti conoscitivi minimi per interpretare fatti che si sono svolti in situazioni e luoghi di cui non tutti hanno conoscenza, né diretta né, spesso, nemmeno mediata (escludendo i superficiali articoli di cronaca di cui sopra). I protagonisti coinvolti in prima persona in uno di questi eventi forniranno da subito materiale per l’elaborazione di queste prime – e già tra loro eterogenee – narrazioni sotto forma di interviste o dichiarazioni, ma solo con il passare del tempo arriveranno a proporne un personale racconto completo. Per ultime capita che vengano prodotte narrazioni in cui l’evento d’origine diviene un semplice pretesto per la costruzione di una narrazione che sappia sedurre il gusto del grande pubblico, in cui le ragioni conoscitive vengono annullate e la complessità mistificata.
Ci sono eventi che diventano perno per una molteplicità di narrazioni, sia per stile che per punti di vista. Quando si tratta di eventi tragici avvenuti in montagna spesso quel che si legge tra le righe dei primi resoconti giornalistici ha il tono sensazionalistico, per poi virare su quello scandalistico nel momento in cui si procede nel tentativo di individuare il fattore unico e determinante – magari nella carne e nelle ossa di un o un’alpinista – della tragedia, in un giochetto che ha poco senso giacché si svolge tutto ex-post. Arrivano poi le ricostruzioni più circostanziate, scritte da chi è in possesso degli strumenti conoscitivi minimi per interpretare fatti che si sono svolti in situazioni e luoghi di cui non tutti hanno conoscenza, né diretta né, spesso, nemmeno mediata (escludendo i superficiali articoli di cronaca di cui sopra). I protagonisti coinvolti in prima persona in uno di questi eventi forniranno da subito materiale per l’elaborazione di queste prime – e già tra loro eterogenee – narrazioni sotto forma di interviste o dichiarazioni, ma solo con il passare del tempo arriveranno a proporne un personale racconto completo. Per ultime capita che vengano prodotte narrazioni in cui l’evento d’origine diviene un semplice pretesto per la costruzione di una narrazione che sappia sedurre il gusto del grande pubblico, in cui le ragioni conoscitive vengono annullate e la complessità mistificata.
Le narrazioni di quel che accadde nel maggio 1996 durante la discesa dall’Everest da parte di tre spedizioni commerciali, in cui persero la vita tre alpinisti, ben rappresenta la dinamica sopra descritta. Nell’arco di poco tempo su Alpinismo Molotov sono state pubblicate due recensioni che riguardano diverse narrazioni di quei tragici fatti: quella del film Everest scritta da Martina Gianfranceschi (qui) e quella proposta da Roberto Gastaldo del best-seller firmato dal giornalista-scrittore-alpinista Jon Krakauer dal titolo Aria sottile (qui). Niente più di un caso, in Alpinismo Molotov non era stato programmato di affrontare questi diversi punti di vista a riguardo dei fatti che si svolsero oramai 20 anni fa nella zona della morte sull’Everest. Allo stesso modo io non avevo programmato la lettura della ricostruzione da parte di Anatolij Bukreev – che fu una delle guide di una delle tre spedizioni coinvolte nei fatti – scritta a quattro mani con il giornalista Gary Weston Dewalt. L’essermi trovato tra le mani questo libro – dal titolo Everest 1996 – non ho potuto non interpretarlo come un hasard objectif molotov e pertanto, senza attesa, l’ho letto di gran lena. E ora ne scrivo.
Everest 1996 è un resoconto privo di fronzoli, già dal titolo. Bukreev prese la decisione di scriverlo dopo essere stato travolto dal vortice dei reportage giornalistici che si concentrarono sulla tragedia – affidandosi al supporto offertogli dal coautore Weston Dewalt anche per sopperire alle sue difficoltà con la lingua inglese che già nelle prime dichiarazioni strappategli dai giornalisti al suo rientro dal Nepal avevano creato ampi margini di fraintendimento – e per rispondere alle accuse che Krakauer aveva rivolto al suo operato nell’articolo pubblicato sulla rivista Outside e riconfermate all’interno di Aria Sottile. La lettura del libro lascia chiaramente l’impressione che questa risposta di Bukreev nascesse anche come bisogno personale di mettere a fuoco quali erano state le manchevolezze e le ragioni che avevano portato alla tragedia, senza cedere alla polemica ma, al contrario, mettendo sotto analisi con umiltà innanzitutto le proprie scelte, esponendo le sue ragioni, ricostruendo a partire dalla sua importante esperienza nell’alpinismo d’alta quota i fatti che aveva vissuto. Allo stesso modo, consapevole che il suo punto di vista era parziale e comunque influenzato dalle durissime condizioni ambientali in cui aveva operato, il supporto di Weston Dewalt si intende chiaramente come il tentativo di allargare la visuale comprendendo – sia nel senso di raccogliere che di sapersi spiegare – le testimonianze degli altri alpinisti coinvolti nei fatti.
Se pensiamo al tipico récit d’ascension questo di Bukreev è assai lontano da quel modello, assume quasi i tratti di un récit collettivo in cui si alternano parti in cui Bukreev racconta in prima persona lo svolgersi dei fatti, a parti in cui Weston Dewalt riporta le dichiarazioni degli altri alpinisti coinvolti o propone riepiloghi dei fatti sulla base delle testimonianze da lui raccolte. Non c’è traccia nel libro di senso di rivalsa, non si cede alla tentazione di individuare un colpevole e non si muovono accuse. Traspare a tratti la reazione dettata dall’amor proprio tipica di quando ci si sente accusati ingiustamente, ma a riprova delle intenzioni di Bukreev questa viene ammessa esplicitamente da lui stesso, addirittura posta in relazione a quello che definisce il suo «difficile carattere». Il risultato è una disamina attenta e scrupolosa dei fatti, che tende a evidenziare la complessità piuttosto che estrapolare dei singoli fatti per caricarli di un peso che può determinare una certa lettura semplificatoria degli eventi. Everest 1996 rappresenta in generale una critica articolata alle spedizioni commerciali in alta quota, non accusabile di pregiudizialità tenuto conto dell’esperienza di Bukreev che così ne dà conto in una lettera al Direttore di Outside ai tempi della diatriba con Krakauer: «Nella mia carriera sono salito in vetta all’Everest tre volte; ho scalato sette dei quattordici Ottomila, qualcuno più di una volta per un totale di dodici ascensioni su montagne oltre gli ottomila metri, sempre senza usare bombole di ossigeno.»
Prima di dedicare un po’ di spazio alle considerazioni di Bukreev sulla sua formazione alpinistica nella scuola sovietica e sulla sua critica alle spedizioni commerciali è giusto riportare brevemente le critiche mossegli da Krakauer e le sue risposte in merito: Bukreev nel giorno della salita finale alla vetta dell’Everest sarebbe stato non vestito adeguatamente e avrebbe agito con incoscienza non facendo ricorso all’ossigeno supplementare, concause che avrebbero obbligato a scendere Bukreev dalla vetta al Campo 4 senza attendere i clienti della sua spedizione e gli altri alpinisti impegnati nella salita.
Bukreev a proposito rispose mostrando un’immagine scattata in vetta dove è ritratto con una tuta termica e, a proposito dell’uso dell’ossigeno, ricordando le diverse salite da lui effettuate senza ossigeno oltre gli ottomila metri. Tenuto conto dell’imprevedibilità delle reazioni fisiologiche a quelle quote segnalò anche che – fino al momento della discesa dalla vetta – cautelativamente nel proprio zaino aveva con sé una bombola e il relativo erogatore. Inoltre, la discesa al Campo 4 venne concordata con il suo capospedizione Scott Fischer (uno dei cinque alpinisti che morirono lungo la discesa); lo scopo era quello di poter permettere a Bukreev, nell’eventualità sorgessero dei problemi, di salire in soccorso agli alpinisti in difficoltà (e in effetti Bukreev salvò la vita a tre alpinisti nelle ore successive).
Bukreev non aveva niente, nel leggere le sue parole, dello spaccone.
Come anticipato vale la pena soffermarsi sulle parti del libro in cui si fa riferimento alla scuola alpinistica sovietica in cui Bukreev si era formato, scuola i cui alpinisti hanno dato un importante contributo alla storia dell’alpinismo anche se poco conosciuta rispetto ad altre tradizioni alpinistiche. In Everest 1996 i riferimenti riguardano in particolar modo la situazione creatasi dopo il dissolvimento dell’Unione Sovietica, che Weston Dewalt così descrive:
«L’attività alpinistica era decimata. Molti scalatori della generazione di Bukreev, alcuni dei più forti alpinisti al mondo, erano ridotti quasi alla povertà. Per sfamare le famiglie avevano dovuto accantonare le loro ambizioni e mettersi a lavorare in rifugi di montagna o a insegnare lo sci ai figli dei boss della mafia, a fare qualsiasi cosa pur di mettere del pane sulla tavola.» [1]
Bukreev non aveva rinunciato, dopo la cittadinanza kazaka acquisita nel 1991, al suo progetto di scalare i 14 Ottomila e cercò in ogni modo di poter raggiungere questo obiettivo mettendosi a disposizione delle spedizioni commerciali che, con i compensi riconosciutigli, rappresentavano l’occasione per mantenersi e, al contempo, tenersi allenato alle alte quote. Nel 1996 quando partecipò alla spedizione organizzata da Mountain Madness aveva ancora – anche se non era la prima spedizione commerciale a cui partecipava come guida – un’esperienza limitata come guida accompagnatrice di spedizioni commerciali, a proposito – oltre a interrogarsi a più riprese durante il libro sul ruolo richiestogli all’interno dell’organizzazione della spedizione e dedicando le prime cento pagine del libro alla descrizione delle fasi di ideazione, promozione e organizzazione di una spedizione – l’alpinista kazako, introducendo anche la sua personale critica a questa tipologia di spedizione, scrive:
«[…] ho sempre riservato delle critiche nei confronti delle spedizioni commerciali. Sono cresciuto alpinisticamente nella tradizione della scuola russa d’alpinismo d’alta quota, dove si mettevano in primo piano lo sforzo collettivo e il lavoro di squadra, mentre le ambizioni personali erano relegate in second’ordine. La nostra pratica d’allenamento degli alpinisti consisteva nello sviluppare la loro esperienza e confidenza con la montagna in tempi lunghi, cominciando con montagne relativamente basse e promuovendoli agli Ottomila quando erano pronti.»
E aggiunge:
«Ma qui, come nelle altre spedizioni commerciali, avevo l’impressione di non essere stato assunto per preparare i clienti a scalare la montagna, ma per adattare la montagna ad essere salita da loro.» [2]
Con quest’ultima frase Anatolij Bukreev illumina in maniera precisa e sintetica la criticità principale delle spedizioni commerciali, non solo dal punto di vista etico del rapporto tra uomo e montagne, ma anche dei rischi connessi a un tale approccio, della devastazione ambientale dell’alta quota e dell’esclusività su base economica ancor prima che di preparazione alpinistica al tentativo di ascesa di un Ottomila.
Chiudo questa recensione con il dovuto omaggio all’alpinista Anatolij Bukreev, salitore di 10 dei 14 Ottomila e morto travolto da una valanga nel 1997 nel tentativo di salita di quello che doveva essere l’undicesimo della sua carriera, l’Annapurna. La sua straordinaria carriera alpinistica – complessivamente 18 ascese (e discese) da cime oltre gli ottomila metri di quota, quattro di cui sull’Everest, quasi tutte senza ricorso all’ossigeno supplementare – può forse essere racchiusa, oltre alle sue straordinarie doti fisiche, nella sua attenzione alla samocuvstvie, termine russo che compare più volte in lingua anche nelle pagine di Everest 1996 e che significa (dalla Nota del traduttore) «disposizione d’animo e anche l’insieme dello stato fisico ed emozionale della persona».
[1] Anatolij Bukreev, Gary Weston Dewalt, Everest 1996, pag. 53.
[2] Cfr. Bukreev, Weston Dewalt, pag. 91.





robgast69
| #
Leggendo questa tua recensione mi rendo conto che Krakauer passando dall’articolo (che non ho letto) al libro deve aver davvero ammorbidito molto la sua critica a Bukreev. Infatti nel libro non parla più di abbigliamento e più in generale il comportamento di Bukreev sembra solo un tassello della più generale disorganizzazione che viene attribuita alla spedizione di Scott (che però quel giorno perse ‘solo’ un uomo, e non uno dei clienti, contrariamente a quanto avvenne per la spedizione di Hall, che Krakauer giudica più organizzata).
Andando oltre la diatriba tra i due trovo che le osservazione citate nell’articolo (particolarmente l’ultima) centrino il problema, ovvero la presunzione di voler portare la cima dell’Everest alla portata di tutti. Concetto che c’è anche in ‘Aria sottile’, ma che qui mi pare sostenuto con maggior forza, e che penso sia la base su cui alcuni errori di valutazione hanno costruito quella tragica giornata.
Mr Mill
| #
Premessa. Essendo un caso oggettivo (o prosaicamente per la fottuta risonanza) che io abbia letto Everest 1996 e poi deciso di scriverne, non ho avuto – ancora – modo di leggere Aria Sottile.
Provo a risponderti cercando di allargare l’inquadratura, evitando di prendere posizione a favore della tesi di Krakauer o della non-tesi di Bukreev. Quest’ultimo non si sbilancia infatti nell’individuare colpe personali, ma piuttosto evidenzia limiti che hanno contribuito a innescare poi la catena di fatti che portò ai tragici eventi. In particolare una manchevolezza relativa alla salita specifica del 10 maggio 1996 – e riguarda entrambe le spedizioni, quella guidata da Rob Hall come quella guidata da Scott Fischer – viene sottolineata e, in effetti, balza agli occhi anche per chi non ha esperienza di scalate a grandi quote: il giorno della salita finale dal Campo 4 alla vetta non venne indicato ai salitori un orario limite entro il quale tornare al Campo 4, che si fosse raggiunta la vetta o meno. C’è chi raggiunse la vetta alle 17,00; altri che la raggiunsero in precedenza, ma già dopo le 14,00 che è l’ora solitamente indicata come limite massimo, e si attardarono per più di un’ora a scattare fotografie e festeggiare la “conquista”. Questo fece sì che gli alpinisti si trovarono ancora sulla via di discesa quando il tempo atmosferico mutò (repentinamente sì, ma come può succedere sull’Everest) e comportò anche un consumo maggiore rispetto a quello previsto di ossigeno integrativo e – al suo termine – ognuno dovette fare i conti con un fattore di affaticamento supplementare.
Come spiegare questa scelta, questa grossolana pecca organizzativa? Probabilmente proprio con la natura stessa delle spedizioni commerciali, dove l’arrivo in vetta del maggior numero di partecipanti alla spedizione è un fattore importantissimo di promozione degli organizzatori nel “catturare” clienti per le spedizioni venture. Inoltre, a fronte di un costo per la partecipazione “importante” – per la spedizione di Mountain Madness Bukreev e Weston Dewalt scrivono pari a 65 mila dollari – la decisione del capo-spedizione di dire a un cliente “no, tu torni a casa senza aver raggiunto la vetta” non è semplice da attuare e non è una buona pubblicità, perché se la guida in questi casi, come scrive Bukreev, deve adattare la montagna alla salita dei clienti, le colpe di un fallito tentativo ricadono sull’incapacità dell’organizzazione nel predisporre adeguatamente la via di salita e sulle scelte effettuate dal capo-spedizione. Stringendo al massimo credo che si possa tranquillamente indicare fra i fattori che aumentano esponenzialmente i rischi per i partecipanti a una spedizione commerciale la logica della concorrenza – business is business! – che, se proprio non determina, influenza in modo pesantissimo ogni scelta, dalla prima fase di ideazione di una spedizione di questo tipo, alla selezione dei clienti, l’approvvigionamento (penso alle bombole d’ossigeno, ad esempio), fino alle scelte sul “campo”: la programmazione dell’acclimatamento per i clienti, l’approntamento della via di salita, ecc.
robgast69
| #
D’accordissimo. In più bisogna tenere presente che Krakauer era presente come inviato di ‘Outside’, e tanto Fischer che (ovviamente) Hall lo sapevano. Il che significava che quella salita avrebbe fatto alle due ‘agenzie’ una pubblicità impareggiabile, quindi per entrambi quella non era una salita come le altre. E anche questa distorsione non ci sarebbe stata nel caso di una spedizione non commerciale. In particolare è pensabile che Hall, che si era trovato con una spedizione di livello eccessivamente basso (detto da uno che i 4000 li ha passati una volta nella vita suona molto ridicolo, ma intendo basso rispetto all’obiettivo, non in senso assoluto, magari avessi io quel livello) e alle 15, un’ora dopo l’orario considerato limite per una discesa sicura, si trovava ad aver portato in vetta solo due clienti su otto, nel prendere le sue decisioni abbia ricevuto da questo fatto una notevole pressione aggiuntiva.
Mr Mill
| #
La rivista Outside – da quanto scrivono Bukreev e Weston Dewalt – prima trattò con Fischer sulla partecipazione di Krakauer alla sua spedizione, tirando sul prezzo proprio perché ben consci del volano promozionale che avrebbe rappresentato per Mountain Madness la pubblicazione di un articolo sulla rivista a conclusione della spedizione (e scommettendo – i primi e il secondo – sul successo della salita da parte di Krakauer). Rob Hall fu però chi chiuse l’accordo, con un ribasso che Fischer non poteva permettersi.
Ecco, questo solo come ulteriore esempio di come si gioca la partita fin dall’ideazione di una spedizione commerciale…