Il cammino non si arresta, continuano le evasioni della “quarantena molotov”. La militarizzazione sta dilagando, tra strategie del capro espiatorio e denunce appioppate più per mostrare i muscoli che altro. È toccata a Pietro De Vivo, tra le altre cose parte della banda di Alpinismo Molotov a cui va la nostra solidarietà, che l’ha raccontata in un post su Giap; e utilissima potrà rivelarsi anche la lettura del commento giuridico di Luca Casarotti, che occupa le seconda parte del post.
In questa puntata le “normalissime” evasioni mutano in “necessarie”, così come necessario è raccontare queste escursioni come ogni altro atto di resistenza alla narrazione egemonica che ci vuole ammutolit*.
Il perché lo ha spiegato bene Wu Ming 1:
Se ne esce socializzando la resistenza, estendendola, raccontandola, lavorando perché il racconto di queste buone pratiche fori la membrana almeno in un punto. Più persone danno testimonianza, meno opprimente sarà il clima.
Non importa se queste “necessarie evasioni” si svolgono nell’arco di poche centinaia di metri attorno al proprio domicilio – come benissimo mostra Mariano Tomatis nella pillola che chiude questo post –, conta muovere nello spazio e nel tempo i nostri sguardi.
In questa seconda puntata già sono presenti contributi che abbiamo ricevuto via posta elettronica da lettrici e lettori, l’invito a tutte e tutti è quello di seguire l’esempio: evadere, raccontare quello che i vostri sensi (anche il sesto) hanno percepito mentre camminavate, raccontarlo e inviarlo a info@alpinismomolotov.org.
Noi ci impegniamo nel continuare a dare spazio a queste rassegne di racconti: scriviamo collettivamente la quarantena molotov.
Il racconto di M1
Ho camminato fino all’ufficio – scrivere questa frase suona come un’auto-denuncia in stile radicale.
Ho diligentemente compilato la mia auto-certificazione per motivi di lavoro – e poco importa che in caso di controllo, chi avrebbe dovuto garantire che non stessi auto-certificando il falso ero io stessa, essendo io la datrice di lavoro. La burocrazia dell’assurdo.
Un chilometro e mezzo all’andata, un chilometro e mezzo al ritorno. Benché auto-giustificata, ho percorso stradine secondarie, ho scrutato le vie prima di avventurarmici: volevo evitare il più possibile noie e controlli, i possibili abusi di autorità che possono fare ciò che vogliono grazie a norme vaghe, contraddittorie e prive di fondamenta giuridiche.
Ho camminato a passo veloce, ho incontrato pochissime persone: cinque o sei in fila, ben distanziate, all’ingresso di un alimentari, qualche cane che regala brevi sorsi di libertà ai suoi padroni, un paio di vecchietti senza apparente mèta alcuna, tre punk senza più bettola di riferimento, un corridore solitario, dalle gambe robuste e dalla faccia contratta. Non ho notato nulla di ciò che i proto-fascisti websocial di questi giorni lamentano ogni cinque minuti: nessun pericoloso assembramento. Tutte le persone che ho incontrato, una ventina in tutto, erano diligenti nel rispettare le distanze di sicurezza. Pure esageravano, distanziandosi di diversi metri l’una dall’altra.
Ho notato invece qualcosa di cui nessuno – o, meglio, troppi pochi – parla: il silenzio.
Non il silenzio del traffico ridotto al lumicino, non il silenzio delle assenze. A impressionarmi è il silenzio delle presenze. Le persone non si parlano, si scrutano in cagnesco. Traspare, dalla loro prossemica, una paranoia montante, violenta, pronta ad esplodere per un nulla.
Mi hanno spaventato, quanto mi terrorizza l’autoritarismo galoppante.
Ho accelerato l’andatura, aperto la porta dell’ufficio e per qualche minuto, il tempo di sbrigare le pratiche necessarie, mi sono sentita al sicuro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro e sono di nuovo in strada. Questa camminata, nata da una necessità lavorativa, s’è rapidamente trasformata in un calvario. Vorrei essere già al nostro appartamento, da dove, poche ore prima, non vedevo l’ora d’evadere.
A casa, al telefono con la genitrice, ho avuto conferma delle mie impressioni: anche lei ha notato lo stesso silenzio, anche lei è tornata al suo domicilio, più spaventata dagli umani che dai rischi sanitari.
Mi domando dove finiremo, ora che la solidarietà, l’istintivo afflato che ci lega agli altri esseri della nostra specie è scomparso, evaporato in una nuvola di panico.
È una domanda retorica, che tanti prima di me si sono posti. Finiremo in un burrone e a calci schiacceremo i nostri vicini.
Per il piacere e il gaudio del potere.
Il racconto di D
Martedì mattina. Dopo la lezione di scienze, la didattica a distanza (che orrore le distanze), decisi di mettere in atto il pensiero con cui mi svegliai quella mattina: percorrere qualche chilometro della città metropolitana, attraversare il confine del capoluogo per recarmi nel luogo in cui tengo Cortázar parcheggiato, un camperino degli anni Novanta, così denominato in ricordo dello scrittore argentino inventore del glíglico.
Qualche piccola infrazione/illegalità ho commesso nella mia vita, e ad essere sincero ho avuto spesso la fortuna di incontrare nelle “forze dell’ordine” una certa umanità (cosa abbastanza strana, eppure ho avuto questa fortuna). Questa volta però, fin dal momento in cui sono entrato in auto per attraversare un pezzetto della città, ho provato delle sensazioni diverse. Era come se mi aspettassi un posto di blocco da un momento all’altro, qualche esaltato in divisa e le conseguenti rotture di coglioni. E poi la cosa mi puzzava già di esercito in strada. Inoltre era legale ciò che stavo facendo (almeno per me lo era, ma per la “legge”?). Andare semplicemente nel posto in cui si trova Cortázar. L’intenzione? Solamente vederlo, metterlo e lasciarlo in moto per una decina di minuti; la batteria a terra è una brutta seccatura.
Comunque arrivo al parcheggio e nel piccolo giardinetto verde, a pochi metri di distanza dal camperino, trovo due ragazzi: uno seduto nella panchina beveva la sua birra direttamente dalla bottiglia, l’altro in piedi chiacchierava con lui. Mentre Cortázar era in moto sentivo le loro voci, parlavano di cose semplici, banali, leggere. Le loro parole mi hanno tenuto compagnia per qualche minuto e mi hanno fatto pensare alle nuove formule autoritarie (“dovete stare tutti chiusi in casa, non dovete uscire!”), alle delazioni che si ripetono costantemente dalla mattina alla sera. Mi ha fatto piacere vedere e sentire quelle due persone, e poi quel sole quasi primaverile. Spento e chiuso il camperino non sono risalito in auto, in me ha prevalso la volontà di camminare, d’altronde sono un escursionista.
Camminare e pensare… camminare e resistere!
E tu, a che pensi?
Il racconto di A1
Credo che il mio amore per le evasioni sia innato, la prima di cui io e la mia famiglia abbiamo memoria l’ho messa in pratica tra i quattro e i cinque anni. A quel tempo frequentavo il secondo o terzo anno d’asilo – la scuola materna, pardon – e con G. ci organizzammo. Il piano messo a punto era semplice ma fu efficace: il cancello d’ingresso della materna – statale – restava aperto tra le 7:45 e le 9:00 per evitare continui ronzii di citofono causati dall’andirivieni dei genitori.
A quel tempo io e G. avevamo cominciato a sfrecciare sulle nostre biciclette e ottenemmo il permesso di maestre e genitori a recarci a scuola in sella.
Innumerevoli osservazioni, timori, poi finalmente ecco il giorno: come sempre arrivammo presto – entrambe le nostre madri lavoravano –, studiammo la situazione e, nel momento di ressa dovuta all’arrivo massiccio dei nostri compagni, ci infilammo di soppiatto al fianco di gambe materne, sgattaiolammo fuori dalla porta d’ingresso, inforcammo le biciclette varcammo il cancello e via, a zonzo per il paese!
Ricordo addirittura una tappa da mia nonna paterna, eleggemmo a scusa l’apertura non comunicata e ritardata dell’asilo, alle 10:00 (grazie Italia dei continui scioperi d’allora) e spiegammo che i nostri genitori, non sapendo come organizzarsi, ci avevano depositati lì.
Nonna ci offrì perfino la colazione – la seconda – con tanto di cioccolatino Lindor, beato zio svizzero. Poco prima delle 10:00 salutammo – nonna non era preoccupata, l’asilo sulla stessa sua via – e riuscimmo a assaporare ancora qualche minuto di libertà quando un grido ruppe la gioia: G. fu accalappiato da una delle tante maestre a caccia. Mi fermai, tornammo a scuola – in castigo – e da allora furono proibite le biciclette e il citofono riprese a ronzare quotidianamente.
Ora, anni e anni dopo, mi sento quasi ridicolo a raccontare questa.
Appuntamento al centro commerciale, io M. e M. La prima M., la mia compagna, lavora ancora – servizi essenziali, alla persona – e ha un cruccio: prima della gran serrata voleva andare dal parrucchiere, la ricrescita si faceva evidente e lei non vuole andare al lavoro disordinata, non è da lei.
Programma e appuntamento saltati, tutto chiuso.
Ci troviamo così con la seconda M. al centro commerciale, una spesa veloce, l’accordo e via, ognuno per la sua strada.
Poco dopo eccomi a bussare a un negozio chiuso, M. si avvicina circospetta, scruta e apre; seguono lunghe e dettagliate istruzioni che cerco di memorizzare, M. mi capisce, sa che non ce la farò mai. Non sono avvezzo a queste cose, da più di trent’anni i miei tagli sono domestici e del tutto casuali.
Stiliamo un pizzino.
M. mi rassicura, “se hai qualsiasi dubbio chiama A., ti spiegherà tutto in diretta”.
Mi dirigo verso casa, qualche forza dell’ordine, meno del solito però, così il pensiero si fa concreto. Guardo Z., lo accarezzo, lui mi guarda e approva, non gli va di rincasare.
“Optiamo” per un trekking proto-urbano, il primo della mia vita. Ci dirigiamo verso la provinciale, la strada più trafficata che c’è, scelgo di passare davanti la caserma dei CC, Z. ama fermarsi là per i suoi bisogni e in questo modo io posso controllare la situazione. Tutto tace, la giornata pare molto tranquilla, via!
Pochi metri ed ecco la provinciale, ci posizioniamo nel suo mezzo, sulla linea di mezzeria, e procediamo verso nord. Battezziamo il nostro trekking passeggiata delle galline: avete mai provato a mettere la testa in terra, rasa al suolo a una gallina e tracciare una linea retta col gesso? Resterà come ipnotizzata a scrutare la linea fino alla sua fine, più lunga sarà la linea più la gallina resterà in posizione. Questo faremo, ci limiteremo a osservare una linea, “lo so Z., preferiresti il panorama, pazienta, questo è un esperimento vero”.
Quanta linea ci sarà concessa, quanta ne percorreremo, quanto sono diligenti i nostri concittadini?
La strada è deserta, si cammina; alla vista dei prati Z. strappa, vorrebbe andarci per una corsa, per rotolarcisi, “al ritorno Z., promesso, ora vieni di qui”.
Raggiungiamo la porzione di viale alberato, quei duecento metri con le ultime case prima dei campi, il viale è un tripudio di cinguettii, mai sentita una cosa del genere. Continuiamo a avanzare fino al limitare del paese, oltre solo l’ultima frazione, nessuno, nessun rumore nessun suono, solo un incantevole sottofondo d’uccelli e piccoli animaletti, proseguire oltre sarebbe davvero troppo.
“Andata Z., abbiamo camminato circa due km in mezzo a una strada di percorrenza, soli, senza incontrare anima viva, quando mai ci ricapiterà?”.
Torniamo dai campi, più sicuro e discreto, nonché molto più appagante, a casa telefono ad A., sono nervoso, una tinta professionale manco so che sia, A. spiega tutto pazientemente e, un’ora e una doccia e molteplici dubbi dopo, terrorizzato, sudando freddo, io e M. controlliamo il risultato.
Sono un discreto acconciatore, M. gongola soddisfatta, sarà una bella serata, la giornata è andata bene di sicuro.
Il racconto di Y
Passata la febbre ho iniziato a mettere il naso fuori di casa almeno tre volte al giorno, in compagnia dei cani soprattutto. Premetto che qua a Vienna non ci sono (ancora) le stesse restrizioni assurde, contro il mondo e contro la vita, che con gli ultimi decreti stanno limitando la libertà in Italia. Da poco più di una settimana sono chiusi bar e ristoranti e tutte le altre attività non indispensabili, ma si può stare fuori in compagnia al massimo in cinque persone, si può andare nei parchi e si può correre, senza che ci siano poliziotti e sceriffi pronti a fermarti. E la gente nei parchi a camminare e correre ci va come prima, che stare tutto il giorno in casa si può diventare matti.
Tutto bene, quindi? No, certo che no. In giro non ci sono più bambini, almeno nei luoghi pubblici del mio quartiere. Le aree giochi – tutte, anche i campetti di calcetto e di basket – sono state chiuse con il nastro bianco e rosso. Il traffico è parecchio diminuito, specialmente dopo pranzo la quantità di auto e camion in giro è molto molto minore. In centro non ci sono ancora andato ma lì credo che non ci sia nessuno, visto che turisti non ce ne sono più in giro. Ma è di sera che le cose diventano spettrali e il silenzio riempie lo spazio. Esco di casa per l’ultimo giro, prima di andare a dormire, intorno alle 23:00, non faccio sempre lo stesso giro cambio ogni sera così da non renderlo noioso e da poter dare un’occhiata in giro. Nelle ultime sere, qualunque direzione decida di prendere, per strada ci siamo solo noi. Mi guardo intorno e non c’è nessuno per centinaia di metri, niente. Nessuno sulla Mariahilferstrasse, nessuno sulla Sechshauserstrasse, le due strade su cui di solito c’è più movimento. Sento i miei passi che risuonano, nient’altro. Contrariamente al solito ci sono molte finestre con la luce accesa. Proseguo la passeggiata fino al parchetto che non ha l’area cani, non c’è nessuno e libero comunque Gea e Sirius così che possano correre un po’. Mi fermo a guardarmi intorno e ascolto il peso del silenzio, di una qualità che non ho mai sentito prima a Vienna ma solo in montagna. Continuo il giro senza rimettere i guinzagli, vedo che per centinaia di metri non rischio di incontrare nessuno. Passo sulla via che mi riporta verso casa, i negozi chiusi da giorni hanno tutti il cartello in cui spiegano il perché sia tutto chiuso e augurano a tutt* di restare in salute: Bleibt gesund! Anche lo studio di architettura, dove di solito vedo che c’è sempre qualcuno a lavorare fino a molto tardi, è vuoto e hanno portato via anche i computer, così che possano lavorare da casa, mi dico. Boh, chissà. Nella piccola pizzeria che fa solo asporto invece vedo che sono aperti e lavorano, un rider passa di corsa per fare una consegna. Una volta davanti al portone di casa tiro su lo sguardo e vedo che i vicini hanno affisso un cartello sul vetro di una finestra, la scritta dice Grenzenlose Solidarität: Solidarietà senza confini.
Il racconto di E e M2
Fugulìns
Un
prima
timidu
al à metût four
al ciâf
po’ doi
po’ trec
po’ duta ‘na lûs.
Oh, se podarés
dî
ch’i son tornâtz!
Lucciole.
Una\prima\timida\ha messo fuori\la testa\poi due\poi tre\poi tutta una luce\Oh, se potessi\dire\che sono tornate!
Federico Tavan (1949-2013)
Tipico per noi fare una camminata nel piano. M. è politraumatizzato, operato al piatto tibiale e ai legamenti crociati anteriori, e scarpinare in salita per lui non è piacevole né rilassante quindi, anche se la montagna di casa, lo Joûf, è molto più vicina, optiamo per la solita camminata nei magredi della Valcellina, che comunque consideriamo *in prossimità* di casa nostra. E., di buon cuore, anche se sospira e sbuffa, è contenta di poter passeggiare, guardare lontano e cogliere le novità offerte dalla vegetazione che proprio in questi giorni si risveglia.
Ci prepariamo gli zaini con due fruttini, l’acqua, il binocolo, la fionda antindroni, un libro, dei sacchetti contenitori (che non si sa mai!) e la radiolina.
Partiamo.
Ci fermiamo da Annarosa per pagarle l’affitto di marzo e lei, dal nulla e sorridendo, ci dice di non preoccuparsi che non ci denuncerà per averci visto fuori casa!
Riprendiamo la strada, la più breve e meno esposta agli occhi dei delatori annoiati del nostro quartiere/paesello libero. Molto silenzio, a parte l’abbaiare dei temibili guardiani dei giardini e il frastornante giallo della forstizia in fiore. Qualcuno fuma in terrazza, più di qualcuno falcia il prato e pota le siepi. Stupiti, in questa desolazione, incontriamo Juà che con la bicicletta arranca sotto il peso della spesa e degli abiti puliti (non ha la lavatrice a casa e va alla lavanderia a gettoni); parliamo di come recuperare dei rullini fotografici ed E. dice di averne alcuni scaduti, che al di là della discutibile resa cromatica, di certo possono essere ancora fotosensibilizzati. Camminiamo in tre, non proprio a distanza di sicurezza perché Juà oscilla trascinando la sua bicicletta mentre noi, che abitiamo assieme, non badiamo ai centimetri che ci separano: diventa un “divertissement gimcanesco”. Arrivati al secondo incrocio, Juà si separa da noi, quindi ciao! più le solite raccomandazioni che M. fa a Juà, di stare sobrio e di non fare le sue tipiche cazzate. Vediamo Juà procedere in direzione di casa sua, mantenendo il suo moto ondoso perpetuo.
Notiamo dei giardini che a stento riconosciamo, che siamo abituati a vedere come selve, e che ora si presentano in perfetto ordine, totalmente addomesticati.
Notiamo lo sventolio di bandiere tricolore, fogli disegnati con gli arcobaleni ed E. inizia a dare pugnetti al vento dato che non può picchiare i proprietari delle bandiere, che altrimenti violerebbe l’obbligo di mantenere la solita distanza di sicurezza! Riempiamo le bottiglie d’acqua alla fonte del cimitero e scendiamo verso il Magredo, su strada asfaltata. M. comincia a raccogliere pezzi di vetro levigati ed E. osserva piante, fiori, insetti e rapaci, che in questi giorni si mostrano stranamente baldanzosi. Camminiamo altri venti minuti prima di scorgere i primi sassi del fiume secco.
Procediamo verso il centro del greto del Cellina, sproloquiando su come potrebbe contenere tutta la nostra comunità senza creare assembramento. Il letto del fiume è largo un chilometro e lungo da qui all’Adriatico, quindi assembramento un cazzo! Camminiamo in equilibrio sui i claps in direzione dei piloni del ponte della ferrovia. Ci sediamo, svuotiamo gli zaini e guardiamo lontano. C’è un altro ponte tra noi e la fine dell’arcobaleno e sul ponte, molti camion da trasporto massi e qualche autobus. Restiamo li una mezz’ora al sole, M. nudo ed E. che fotografa piedi, la grava e chissà che altro con la Rolleiflex.
Accendiamo la radiolina e tutte le frequenze rimandano al virus (che non deve essere nominato!); la stazione d’ascolto scelta è Radio Maria, perché si prende bene e ha pochissimo fruscio: veniamo edotti sull’Indulgenza Plenaria che ci libera da tutti i peccati. Disquisiamo sul fatto che, se ‘sta malattia l’ha mandata dio, è pressoché inutile che il papa chieda al suo datore di lavoro di eliminarla, perché dio non sbaglia e decide nell’inerranza, quindi vuol dire che ci va/ci deve andare bene così!
Alcune nuvole coprono il sole e decidiamo di rimetterci sui passi. Dopo una leggera difficoltà nello scendere dai piloni, troviamo una via e vai!, di nuovo sul magredo, M. a raccogliere pezzi di vetro levigati ed E. ad osservare piante, fiori, insetti e rapaci.
Camminiamo almeno un’altra mezz’ora verso la riva del fiume e risaliamo, tenendoci in equilibrio sui claps come su un precaria linea che divide la nostra quieta e quotidiana normalità e la nuova normalità estranea e allucinante che si sta profilando fuori da noi. Vediamo del ciarpame in giro. M. recupera un vecchio lampadario che userà per suonare e dei vasi di coccio mezzi rotti mentre E. raccoglie dei bulbi e dei polloni, di qualche pianta che lascerà crescere sui nostri davanzali.
Sulla strada del ritorno, piantiamo dei bulbi di tulipano: quelli che Jen, in visita da Berlino, ci ha affidato, con la precisa richiesta di metterli in terra e la speranza che crescano liberi qui nelle nostre zone.
Nel folto degli alberi riconosciamo il vecchio rudere, abbandonato lì dal 73. I muri in pietra sono rimasti intatti e davanti vi è cresciuto un alberello di alloro, proprio nella canaletta di scolo delle acque. Entriamo a visitare le stanze ormai abitate da muschi e edere, M. sempre davanti in esplorazione ed E. titubante sull’uscio senza architrave. Troviamo lì una gran desolazione e qualche ferraglia arrugginita, che M. recupera per la sua collezione.
Il sole si fa sempre più debole, noi ci guardiamo e, senza bisogno di aggiungere parola, torniamo lentamente al sentiero.
Finché rimaniamo nella boscaglia, E. si ferma in continuazione per osservare il sottobosco fitto di pungitopo, violette, primule e prugnoli bianchi, con quelle nuvole di petali che fluttuano ad ogni minimo soffio di vento, creando un morbido tappeto candido che ci accompagna fino alla strada asfaltata.
Passiamo di nuovo di fronte al cimitero e stavolta notiamo il cancello chiuso con due giri di catena, cosa che dovrebbe impedire alle beghine di fare assembramento tra i tumuli e i fiori di plastica scoloriti. Quindi riempiamo le bottiglie d’acqua, un ultimo sguardo ai campi e attraversiamo lo stradone per immetterci nella viabilità cittadina. Come sempre, a questo punto, ci è presa l’indecisione: girare a destra per passare di fronte all’Officina di Claudio con la speranza di potergli fare un saluto oltre la staccionata di legno o procedere dritti per la strada più breve?
Praticamente il solito giro che facciamo il lunedì da tempo.
[Il tutto ascoltando: Screen Shot degli Swans e Santa Maria del Cammino (versione de Il Giannotta, Radio Maria remix)].
Il racconto di M3
– Oggi cerchiamo un sentiero nuovo, ma per arrivarci dobbiamo fare 700 metri sulla strada asfaltata in discesa, fino alla casa del Sindaco. Camminiamo distanziati, non si sa mai, speriamo di non incontrare le guardie.
Siamo fortunati. Abitiamo in un paesino di neanche 100 anime, affacciato sulla Valdichiana, incastrato tra vigne, boschi ed uliveti. Dalla piazza partono i nostri sentieri abituali, gli unici incontri possibili sono con caprioli, cinghiali e forse lupi.
L’età media in paese è altissima, se il virus arriva quassù fa una strage.
– Ecco, qua si entra nel sentiero.
– L’hai visto il Sindaco? Era in cima ad un ulivo a potare.
Siamo in 6: io, mia moglie, i nostri due ragazzi e i piccoli Zorro e Leila, i più contenti in questo periodo di quarantena, sono sempre in compagnia di qualcuno e passeggiano molto più del solito.
– Ma bello questo sentiero, non l’avevamo mai fatto.
– Guarda che spettacolo quella cascata, peccato che c’è poca acqua.
Oggi i cani non si reggono, sono sempre a caccia: sentono una pista, la piccola Leila inizia con suo guaito di richiamo, partono a testa bassa e tornano dopo qualche minuto con la lingua di fuori.
– Allora, qua dobbiamo scegliere in che direzione andare. A destra si scende al Fosso di Helm, a sinistra penso si incroci la Via dei Centauri per poi sbucare alla Baia dei Pungitopo.
Abbiamo dato dei nostri nomi di fantasia ai luoghi ed ai sentieri che percorriamo abitualmente, così per orientarci meglio, tipo: oggi sono arrivato fino all’Acquapark e poi sono sceso a Granburrone.
– È da quando abbiamo guadato il torrente che Zorro non si vede.
– Tranquilla, ci aspetterà come sempre al secondo punto di rendez-vous.
Eccoci a casa senza aver incontrato nessuno, come previsto, dopo quasi 4 km di camminata e dopo poco più di 2 preziose ore d’aria, preziosissime soprattutto per i nostri ragazzi. Loro tornano alle loro nuove attività abituali cioè l’alternanza di videolezioni e PlayStation mentre noi iniziamo a chiederci, come ogni giorno, se domani dovremo tornare a lavorare o se finalmente anche i nostri padroni si decideranno a lasciar tutti a casa.
L’importante è riuscire a tenere la mente in funzione: sapere dove siamo, perché ci siamo arrivati, come fare per uscirne e cosa fare quando prima o poi tutto sarà finito e dovremo affrontare una nuova normalità. Intanto progettiamo nuove evasioni.
I canini sono sfiniti, dovremo trovare il modo di allenarci tutti di più prima della prossima Festa Galattica di Alpinismo Molotov.
Ieri sera poco dopo le 6 qualcuno ha fatto partire l’inno nazionale. Stasera, se mi ricordo, finestre aperte, volume al massimo e mettiamo l’Internazionale.
Il racconto di P
Cammino per le strade del paesello e vedo la gente scarmigliata, in pigiama, affacciata al balcone. Io non mollo: esco, mi lavo, mi trucco, mi scelgo i vestiti. Il film distopico che mi si proietta nella testa si apre con l’inquadratura di un uomo con la tuta e la ciabatte di pezza che compie il suo diritto-dovere d’elettore: ripiegato sul suo portatile apre i battenti alla prossima dittatura. Prendermi cura del mio aspetto mi sembra, per quanto minimo, un atto di ribellione. Oggi però no. Solo un poco di matita sugli occhi, uno zaino al posto
della borsa, un anonimo copricapo invece del mio cappello à la Greta Garbo. Eppure vado in città. Solo che è vietato oltrepassare i confini del comune. Per questo vado in giro un po’ dimessa, per non dare nell’occhio.
Mi piazzo alla fermata. Secondo l’app dell’azienda trasporti il pullman dovrebbe essere qui fra un minuto, ma – altro che sessanta secondi, ne passano seicento – non si vede. Mi sento esposta, non è molto che su
questa strada ho visto passare i carabinieri. Decido di mettermi in movimento e di andare al capolinea, sul lato opposto del paese, un quarto d’ora abbondante di cammino. Cerco la mia faccia più disinvolta,
mentre dentro me è in corso una rissa.
– Non metto a rischio nessuno, vado da casa mia a casa sua!
– Sì, ma ci vai in pullman. Un lebbrosario, praticamente.
– Non ho un altro mezzo mio…
– Irresponsabile!
E via così.
Mentre attraverso la piazza mi viene il dubbio di essere senza biglietto. Apro lo zaino alla ricerca del portafoglio. Riecco la pattuglia. Ficco la testa nello zaino. Se mi fermano che gli dico? Manco sono stata capace di inventarmi una cazzata qualsiasi da impapocchiare sull’autocertificazione. I gendarmi mi guardano e lentamente procedono. Sospiro di sollievo. Doppio: perché il biglietto ce l’ho.
Apro una chat segreta su Telegram: “mi sa che il pullman ha saltato la corsa, mi sposto al capolinea”.
La risposta non tarda: “Vai tranquilla, ti aspetto”.
Passa una jeep dei vigili urbani. Mi guardano. Li guardo, come in quel famoso pezzo di Paolo Rossi. Vanno avanti. Sospiro di sollievo. Arrivo alla fermata. Mi siedo sulla panchina. Il sole cala. Gli ippocastani si risvegliano, aprono le gemme in sfregio a questo sciocco inverno, ma sono troppo angosciata e il dettaglio non mi appassiona.
Ancora la chat segreta che trilla. “Il sito dell’azienda trasporti dice che fra un minuto dovrebbe arrivare”. Ecco il pullman, infatti. Cinque minuti e riparte. Siamo in tre a bordo, alla massima distanza fra di noi. Sono poco schizzinosa di solito, ma cerco di evitare troppi contatti con le superfici della vettura. Ai confini del comune c’è un’altra auto dei carabinieri o forse la stessa di prima. Ecco che fermano uno. Mi sa che si viaggia più al
sicuro in pullman che in auto. Ma il pensiero non mi tranquillizza, il tremore del mezzo si propaga alle membra, devo calmarmi. Tiro fuori un libro dallo zaino, leggerò, mi distrarrò. Però no. Ho pescato a caso dalla pila sul comodino, ho preso Karen Barad, un testo difficilissimo per me. Chi ce la fa a concentrarsi
così tanto, ora?
Mentre passiamo un altro confine comunale, il libro rimane lì, a mezz’aria, ma lo sguardo è altrove. Eppure mi devo inventare una scusa. La città deserta sfila fuori dal finestrino. Il pullman corre, nessuno sale, nessuno scende. Apro la chat: “Se mi fermano dico che stai male”. Risposta: faccetta che sorride con goccia di sudore.
Provo fra me la formulazione: – Sto andando dal mio ragazzo, da giorni è solo in casa ed è molto depresso.
Boh.
Ci siamo, scendo dal pullman. Ora è il pezzo più difficile. Sono circa dieci minuti a piedi fino al suo portone. Cammino rasente i muri. I sensi all’erta. Passo spedito, ma non troppo affrettato. Non dare nell’occhio, il primo comandamento. Roba buona per chi ha il privilegio della normalità. In una traversa rimbombano voci. Ok, giro alla prossima. Entro in paranoia, ma la geolocalizzazione del telefono l’ho tolta? Controllo. Sì, l’ho tolta. Eccomi al portone. Suono al campanello. Mi apre. Per le prossime ore sono al sicuro. Al ritorno pensiamo domani.
Il racconto di A2
Lavoro alla Ausl, non sono eroica né angelica: una semplice impiegata amministrativa tra scartoffie e computer, al massimo mi potrei beccare l’allergia agli acari. Dal 9 marzo negli uffici c’è una pressione soft ma insistente a scegliere il telelavoro, ci ho pensato: 33 anni non sono bastati per abituarmi alla sveglia alle 7, forse sarebbe una buona occasione per ritardarla. Però, significherebbe anche non poter più uscire… poi la consapevolezza: in casa abbiamo 2 computer e 2 figli di 18 e 21 anni che fanno la teledidattica. Mi dispiace, visto che l’azienda non fornisce l’attrezzatura devo continuare a lavorare in ufficio, mi tocca, eh! (che poi, in questi giorni il carico di lavoro è calato verticalmente, tanti fornitori semi-chiusi, quasi tutte le attività di routine sospese per ampliare le terapie intensive. Se ci mettessero a casa d’ufficio per due o tre giorni alla settimana l’attività amministrativa non ne risentirebbe, ma immagino non vogliano creare un precedente, vabbè, lo capisco).
Comunque sia, forte dell’autorizzazione del caposervizio a recarmi al lavoro, continuo a prendere l’autobus tutte le mattine (siete avvertiti: statemi alla larga, sono una bomba batteriologica che cammina), perché l’avversione ad alzarmi presto non mi lascia scelta, invece rincaso a piedi il pomeriggio. Lo faccio da anni, sono circa 5 km, praticamente un trekking urbano che attraversa da ovest a est tutta la città, il momento della giornata in cui il ritmo dei passi mi permette di resettare la mente e seguire i miei pensieri, una pratica di salute psicofisica. In questi giorni il vuoto e il silenzio (senza la temperatura ferragostana!) rendono il centro storico di Bologna davvero magico – osservazione banale, lo so, però non si può fare a meno di rimanerne colpiti – spesso allungo il mio percorso per le stradine secondarie, un po’ per diminuire le probabilità di incrociare una pattuglia, ma anche perché è la mia ora d’aria, meglio farla durare.
Mi dispiace per i ragazzi, stanno accusando pesantemente il colpo. La più piccola ce l’ha messa tutta per prenderla con positività, segue le lezioni on line, fa ginnastica nella sua camera, si organizza con le amiche per videochiamate collettive, ma quando le hanno impedito di fare una passeggiata per i parchi con l’unica amica che abita nei paraggi è sempre più sfiduciata e depressa. A 18 anni hai l’ansia di vivere, inutile dirle “passerà” (passerà?); “porta pazienza”, non è l’età della pazienza.
Il grande è una sfinge. Non si esprime, non esterna il malessere. Ribelle irriducibile negli anni della scuola, che ha abbandonato per fare la maturità da privatista dopo aver ripetuto un anno, sembra non trovi il suo posto nella tragedia nazionale. Senza gli amici è perso, prima erano impegnati H24 in mille progetti grafici e musicali, e ora dove sono tutti? Gli mancano le coordinate interpretative, si direbbe. Ma ovviamente non posso fornirgliele io.
Venerdì rincasando mi sono imbattuta in una scena surreale, di questi tempi: un giovane musicista di strada suonava la chitarra (molto bene) accovacciato a terra accanto all’entrata di un discount di prima periferia. Stranamente le persone mestamente in fila all’entrata non lo infamavano. Gli ho chiesto se non avesse paura della denuncia, mi ha risposto: “Che altro posso fare? A rubare non voglio andare, e comunque non sarei capace”.
Daje chitarrista irriducibile!
Il racconto di F
Scrivo queste righe mentre ho appena appreso che da domani, domenica 22 marzo, in Lombardia si stringeranno ancora di più le restrizioni. Chiuderanno gli uffici, i cantieri e tutte le attività non essenziali, ma non le fabbriche; i giornali online nei titoli riportano anche il perentorio “Stop a sport all’aperto”.
Dall’annuncio della Lombardia “zona rossa”, che dal giorno immediatamente successivo sarebbe stata leggermente scolorita a “zona arancione” (area estesa a tutto il territorio nazionale), un’uscita mattutina e/o pomeridiana l’abbiamo sempre ritagliata nell’isolamento casalingo. Niente boschi e niente sentieri, troppo interni alla città (noi). Le sole possibilità sono state escursioni per il quartiere, a piedi o in bicicletta. In duo, io e mio figlio E., o in trio quando si è unita alla banda mia moglie.
A 5 anni il cosiddetto “distanziamento sociale” è una cattività forzata difficile da gestire, una sofferenza sottile. E a volte per niente sottile: “Sono in prigione, con le sbarre attorno!”, nell’occasione in un cui un altro bambino si è mostrato aldilà della rete che divide due case. E. lo voleva abbracciare, almeno abbracciare se non poteva giocarci insieme. Le quotidiane uscite per il quartiere – durante le quali le distanze con gli altri e le altre passanti sono sempre state assai maggiori di quelle consigliate (e questo non ha richiesto mai particolare attenzione) – una parentesi e una parvenza di normalità. Poche le persone per strada, facce seminascoste dalle mascherine, mani coperte da guanti (sovente i guanti che si trovano al self-service della frutta e verdura del supermercato), sguardi inizialmente sfuggenti per poi farsi, con il passare dei giorni, sempre più distanti e inquisitori.
Negli ultimi giorni E. se l’è giocata per evitare di oltrepassare il cancello di casa, la pressione si sente anche se non si passano le giornate a compulsare tra notizie, quasi-notizie e non-notizie; evidentemente anche se tu, genitore, ti adoperi in ogni modo per riempire le giornate della prole; nonostante, nel nostro caso, la fortuna di avere una striscia di spazio esterno alla palazzina in cui viviamo, stretta tra gli altri edifici di un quartiere cittadino di Brescia urbanisticamente nato negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. Siamo privilegiati, ma questo non mi impedisce di constatare che anche a ‘sto giro dei bambini e delle bambine ce se ne preoccuperà, eventualmente, poi. Sì, perché come scrive Vanessa Niri in questo articolo, oggi e da diverse settimane a questa parte, in Italia ci sono «bambini che vivono con altre 5 persone in 40 metri quadri; figli di coppie che stavano divorziando costrette alla convivenza forzata; bambini che perderanno un totale di due mesi di scuola perché non hanno il computer o non hanno il wifi; bambini ai quali i genitori non sono in grado di spiegare cosa stia succedendo, e che stanno sviluppando per questo ogni tipologia di paranoia e ansia; bambini costretti a convivere 24/7 con genitori violenti, o tossicodipendenti in crisi d’astinenza; bambini che vivono in case dove non arriva la luce del sole; bambini che hanno soltanto la televisione e neanche un giocattolo; bambini che vivono in case senza riscaldamento o con i vetri delle finestre rotti e tappati con il cartone; bambini figli di famiglia monogenitoriale la cui mamma lavora come badante e li lascia da soli l’intera giornata (e a volte la notte); bambini con il papà in carcere in situazione di sovraffollamento e rischio elevatissimo di contrarre il virus; bambini figli di famiglie che lavoravano in nero che si sono trovati di colpo senza neanche un euro per comprare da mangiare; bambini disabili senza aiuto esterno. E la lista, dolorosissima, potrebbe occupare ancora molte righe.» Traumi e danni che l’infanzia (ma anche ragazze e ragazzi più grandi) soffrirà nell’età adulta, che peseranno sul complesso del campo sociale prossimo e venturo. Ma nell’immaginaria “agenda politica” l’infanzia ha sempre un posto esclusivamente decorativo, quando un posto lo trova, così come queste condizioni di sofferenza – come molte altre, a partire dalle diffuse sofferenze psichiche e dalle dipendenze – per le benaltriste ragioni del “Restiamo a casa!” o non trovano spazio o vengono ridotte a capricci del prossimo. Ragioni, ahinoi, che non di rado sentiamo proferire da persone che no, mai te lo saresti aspettato; come se una pressione sistemica avesse definitivamente imposto come egemonica la “modalità predefita”, di cui parlava David Foster Wallace, nelle singole e nei singoli.
Il microfascismo, come il lato oscuro della Forza, alberga dentro ognun_ di noi. Oggi il compito principale d’assumere singolarmente è riconoscerlo e resistergli.
 Linus, Anno LVI, marzo 2020. “E’ il mondo che cigola”, Giovanni Arduino (illustrazione Sergio Algozzino)
Linus, Anno LVI, marzo 2020. “E’ il mondo che cigola”, Giovanni Arduino (illustrazione Sergio Algozzino)
Una delle sere degli scorsi giorni sono uscito solo in una veloce perlustrazione del quartiere, muscoli e corpo me lo richiedevano, la testa voleva vedere. C’era poco da vedere, in verità. E quel poco però diceva molto, moltissimo. Non poca inquietudine mi ha trasmesso. Mentre camminavo in quei momenti ho pensato a questa inquietudine, ho riflettuto, fuori dal facile atto giudicante di segno uguale e opposto a quello che intimamente ci schifa in queste giornate e che imperversa nei media e nei social network, a come potesse agire sul corpo sociale in azione combinata con la narrazione egemonica della costruzione dell’emergenza (linguaggio militare e metafore guerresche, sensazionalismo e ricerca costante della presa emotiva).
Una volta rientrato a casa, incidentalmente, mi sono imbattuto in parole che credo siano una perfetta descrizione del clima di questo periodo. Parole di Giovanni Arduino, stampate sulla carta porosa dell’ultimo numero di Linus, in un articolo dedicato a Stephen King, dal titolo già calzante alla stretta attualità: È il mondo che cigola. Arduino scrive, obbligandomi una volta letto a ritornare più e più volte su questo passaggio in cui chiarisce cosa si debba intendere con “horror”: «Forse bisognerebbe sottolineare che l’horror non è una creatura piena di tentacoli che ti fa bù da sotto il letto, ma qualcosa che ti destabilizza, un senso di spaesamento, di sottile angoscia, l’impressione che qualcosa stia cedendo e traballando nel nostro caro, vecchio mondo. […] L’horror è il quadro quando il quadro non c’è più o non c’è mai stato.» Ecco, queste parole mi hanno permesso di segnare un collegamento che mi mancava: la rappresentazione di ciò che stiamo vivendo è tutta narrata nel registro dell’horror. E se la frequentazione della letteratura – concediamocelo – può in qualche misura avere “addestrat_” a questo registro e immaginario, anche quando gli effetti di quest’ultimo incidono immediatamente nel reale, come valutare e soppesare l’effetto generale su chi nemmeno di questo addestramento è equipaggiato?
Le normalissime evasioni saranno molto o nulla, al pari del granello di sabbia che inceppa l’ingranaggio di un sistema che sta celebrando una apocalisse culturale, la fine di un mondo. Non fermarsi, continuare a camminare domandando è essenziale in questo momento, continuare a cercarsi con gli sguardi e riconoscersi nelle parole. E fare attenzione: è questione di un attimo, e ci si perde davvero.
Il racconto – immagini e voce – di M4
Cartoline dalle Colonne d’Ercole: nei giorni della quarantena per il Coronavirus, un reportage dai confini del mondo.

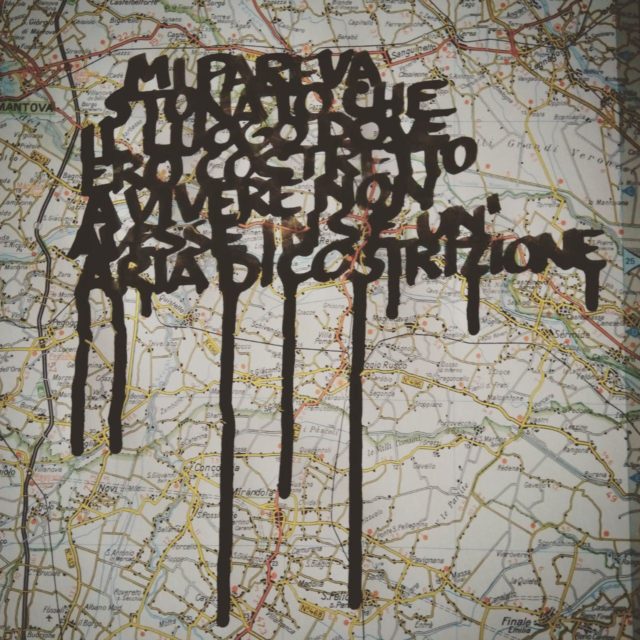



Like cake in a crisis We’re bleeding out. Parte terza | YAMUNIN
| #
[…] parte di ciò che segue l’ho scritta giorni fa ed è stata pubblicata all’interno delle Necessarie evasioni sul blog di Alpinismo Molotov, avrei potuto pubblicarla prima anche quassù ma lo faccio ora che ho […]